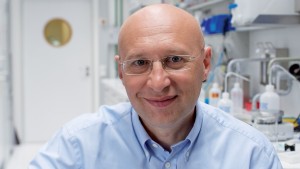 Stefan Hell, Premio Nobel per la Chimica 2014 “per gli studi sullo sviluppo di tecnologie per la microscopia ottica a fluorescenza a super risoluzione”, ha catalizzato la 18esima edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando”, di cui è stato insignito nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi al Castello Giusso di Vico Equense. In questo comune della penisola sorrentina, sede del Museo Mineralogico Campano diretto da Umberto Celentano che ha ideato e istituito il riconoscimento, converge ogni anno il gotha della divulgazione scientifica e culturale. Stefan Hell, direttore del Dipartimento di Nanobiofotonica presso l’Istituto di Chimica Biofisica del Max Planck Institute e professore presso la facoltà di Fisica dell’Università di Heidelberg, è il dodicesimo premio Nobel a ricevere il “Capo d’Orlando”, che annovera tra gli altri insigniti nomi di prestigio come James Watson, Riccardo Giacconi e John Nash. Hell ha condiviso il Nobel 2014 gli americani Eric Betzig e William E. Moerner. Tutti e tre hanno contribuito a superare un limite che si pensava invalicabile della microscopia ottica: la possibilità di ottenere una risoluzione migliore della metà della lunghezza d’onda della luce. Il loro lavoro ha permesso di ottenere microscopi ad altissima risoluzione che vedono cose minuscole, grandi un milionesimo di millimetro.
Stefan Hell, Premio Nobel per la Chimica 2014 “per gli studi sullo sviluppo di tecnologie per la microscopia ottica a fluorescenza a super risoluzione”, ha catalizzato la 18esima edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando”, di cui è stato insignito nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi al Castello Giusso di Vico Equense. In questo comune della penisola sorrentina, sede del Museo Mineralogico Campano diretto da Umberto Celentano che ha ideato e istituito il riconoscimento, converge ogni anno il gotha della divulgazione scientifica e culturale. Stefan Hell, direttore del Dipartimento di Nanobiofotonica presso l’Istituto di Chimica Biofisica del Max Planck Institute e professore presso la facoltà di Fisica dell’Università di Heidelberg, è il dodicesimo premio Nobel a ricevere il “Capo d’Orlando”, che annovera tra gli altri insigniti nomi di prestigio come James Watson, Riccardo Giacconi e John Nash. Hell ha condiviso il Nobel 2014 gli americani Eric Betzig e William E. Moerner. Tutti e tre hanno contribuito a superare un limite che si pensava invalicabile della microscopia ottica: la possibilità di ottenere una risoluzione migliore della metà della lunghezza d’onda della luce. Il loro lavoro ha permesso di ottenere microscopi ad altissima risoluzione che vedono cose minuscole, grandi un milionesimo di millimetro.
Attraverso la nanoscopia, ogni giorno gli scienziati in centinaia di laboratori di ricerca in giro per il mondo possono vedere – per esempio – le singole molecole che compongono le cellule. Possono scoprire come le molecole creano quelle che diventano le connessioni tra le cellule nervose nel cervello, o come il comportamento di alcune proteine influenza lo sviluppo di malattie degenerative come il parkinson o l’alzheimer. La nanoscopia viene anche usata per seguire lo sviluppo delle uova fecondate nel processo che le porta a diventare embrioni.
Per moltissimo tempo la possibilità di analizzare l’evoluzione di una cellula vivente al suo livello molecolare è stata una semplice ambizione, perché mancavano gli strumenti per poterlo farlo. A fine Ottocento la teoria secondo cui non si potesse andare oltre gli 0,2 micrometri nella visione al microscopio divenne piuttosto diffusa. Molti anni dopo, Hell, insieme a Betzig e Moerner, ha dimostrato che il limite teorizzato poteva essere superato e hanno aperto la strada per l’analisi di ciò che si trova nell’estremamente piccolo.
E’ stato proprio Hell di sviluppare la tecnologia STED (stimulated emission depletion, deplezione mediante emissione stimolata) nell’ambito della microscopia. Semplificando, nel sistema sono utilizzati due raggi laser: uno serve per fare in modo che le molecole fluorescenti presenti nel campione che si sta osservando al microscopio brillino, mentre l’altro provvede a cancellare tutta la fluorescenza tranne quella rilevante per l’osservazione nell’ordine del nanometro. La scansione del campione in analisi, nanometro dopo nanometro, permette di ottenere un’immagine a super risoluzione, che supera il limite ipotizzato a fine Ottocento.
Il Premio “Capo d’Orlando” è anche una vetrina dei migliori esempi ed espressioni della comunicazione scientifica e culturale. Il premio “Management culturale” è stato attribuito a Evelina Christillin, presidente del Museo egizio di Torino, tra i più importanti poli museali d’Europa e oggetto di recente rinnovamento che ne permette una fruizione più argomentata, visivamente più ricca e coinvolgente. Mario Orfeo, direttore del Tg1, ha ricevuto il premio per la sezione “Comunicazione multimediale”, mentre per la “divulgazione” è stato assegnato alla giornalista Anna Meldolesi che si occupa di attualità e cultura scientifica per il “Corriere della Sera”. Infine, Adolfo Guzzini, presidente della “iGuzzini illuminazione”, azienda leader nel settore illuminotecnico, ha ricevuto il premio per la sezione “Scienza e Industria” in chiave di innovazione tecnologica. La cerimonia del Premio “Capo D’Orlando” 2016 ha segnato anche la conclusione della mostra “Arte e scienza: 30 artisti illustrano la scoperta del bosone di Higgs al Cern”, allestita nella cornice del Castello Giusso dal Museo Mineralogico Campano in collaborazione con il CERN e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.










