
da Sorrentino | Feb 6, 2019 | Industria, Primo Piano, Servizi Satellitari

Impression
La costellazione Iridium NEXT, sviluppata e realizzata da Thales Alenia Space, è ora interamente operativa. A seguito degli 8 lanci effettuati con successo tra il gennaio 2017 e il gennaio 2019, 75 satelliti Iridium NEXT sono stati tutti dispiegati a orbita terrestre bassa. Più nello specifico, la costellazione opera con 66 satelliti a un’altitudine di 780 chilometri, organizzata in sei piani orbitali, ognuno formato da 11 satelliti l’uno, oltre a nove satelliti di riserva in orbita e sei ulteriori satelliti di riserva a terra. Il contratto per la realizzazione della costellazione Iridium ha un valore di 2,2 miliardi di dollari, pari a 1.7 miliardi di euro. La sfida principale per Thales Alenia Space è stata quella di dispiegare un sistema satellitare completo e complesso end-to-end pronto all’uso, assicurando al contempo compatibilità tra le generazioni precedenti e attuali di satelliti Iridium. Questa è la prima volta che un operatore e un costruttore hanno lavorato fianco a fianco per sostituire una costellazione completa di 66 satelliti, uno per uno, senza alcuna interruzione di servizio per gli utenti. La costellazione Iridium NEXT rappresenta l’avanguardia del presente in termini di tecnologia e flessibilità. È caratterizzata dalla copertura globale e dalla sua indipendenza dal segmento di terra locale, in quanto ogni satellite è collegato ai quattro satelliti più prossimi: quello anteriore, posteriore, a sinistra e a destra. Indipendentemente da dove gli utenti si trovino sulla Terra, in mare o in volo, Iridium fornisce la copertura che permette loro di comunicare. Questo genere di accesso diretto al satellite, sia per ragioni di trasmissione o ricezione, significa che sono disponibili comunicazioni affidabili, anche in caso di disastri naturali o conflitto, in zone isolate, o per fornire comunicazioni sicure protette da intrusioni e pirateria.

da Sorrentino | Feb 4, 2019 | Astronomia, Primo Piano
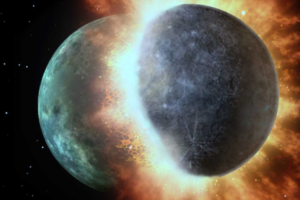 Hanno più o meno la stessa dimensione, circa una volta e mezza il raggio della Terra, ma una eccezionale diversità nella densità media e dunque nella composizione chimica. Sono gli esopianeti Kepler-107b e Kepler-107c, due super-terre calde che hanno masse rispettivamente di circa tre e nove masse terresti e orbitano attorno alla loro stella a distanze molto ravvicinate da essa: 6,7 e 9 milioni di chilometri rispettivamente, cioè il 4,5% e il 6% della distanza Terra-Sole. A caratterizzarle è stato un team internazionale di ricercatori guidati da Aldo Bonomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) a Torino, grazie ai dati raccolti dallo spettrografo HARPS-N installato al Telescopio Nazionale Galileo sulle Isole Canarie. Lo studio ha mostrato che la super-terra più massiva e densa Kepler-107c contiene nel suo nucleo una frazione in massa di ferro che è almeno il doppio della sua “gemella” Kepler-107b. Tale diversità in composizione può essere spiegata ipotizzando che la super-terra Kepler-107c, poco dopo la sua formazione, abbia subìto un impatto frontale ad elevata velocità con un protopianeta della stessa massa o più collisioni con protopianeti di massa inferiore. Questi impatti avrebbero squarciato il suo mantello roccioso di silicati (composti del silicio, ossigeno e magnesio o altri metalli) riducendone l’abbondanza rispetto al ferro e rendendo così la super-terra Kepler-107c più densa.
Hanno più o meno la stessa dimensione, circa una volta e mezza il raggio della Terra, ma una eccezionale diversità nella densità media e dunque nella composizione chimica. Sono gli esopianeti Kepler-107b e Kepler-107c, due super-terre calde che hanno masse rispettivamente di circa tre e nove masse terresti e orbitano attorno alla loro stella a distanze molto ravvicinate da essa: 6,7 e 9 milioni di chilometri rispettivamente, cioè il 4,5% e il 6% della distanza Terra-Sole. A caratterizzarle è stato un team internazionale di ricercatori guidati da Aldo Bonomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) a Torino, grazie ai dati raccolti dallo spettrografo HARPS-N installato al Telescopio Nazionale Galileo sulle Isole Canarie. Lo studio ha mostrato che la super-terra più massiva e densa Kepler-107c contiene nel suo nucleo una frazione in massa di ferro che è almeno il doppio della sua “gemella” Kepler-107b. Tale diversità in composizione può essere spiegata ipotizzando che la super-terra Kepler-107c, poco dopo la sua formazione, abbia subìto un impatto frontale ad elevata velocità con un protopianeta della stessa massa o più collisioni con protopianeti di massa inferiore. Questi impatti avrebbero squarciato il suo mantello roccioso di silicati (composti del silicio, ossigeno e magnesio o altri metalli) riducendone l’abbondanza rispetto al ferro e rendendo così la super-terra Kepler-107c più densa.
Collisioni giganti fra protopianeti si sono verificate nel Sistema solare e hanno verosimilmente dato origine al sistema Terra-Luna, dopo l’impatto del nostro pianeta con un protopianeta delle dimensioni di Marte, all’elevata obliquità dell’orbita di Urano e alla composizione ricca di ferro di Mercurio. “È però la prima volta che, con ogni probabilità, ne vediamo gli effetti in un sistema planetario extrasolare”, afferma Bonomo, primo autore dell’articolo della scoperta pubblicato sulla rivista Nature Astronomy. “Solo con lo scenario di un impatto fra protopianeti riusciamo a spiegare il fatto che le due super-terre Kepler-107b e c abbiano essenzialmente la stessa dimensione ma composizioni così diverse. Ne siamo rimasti sorpresi”. Le due super-terre fanno parte del sistema planetario Kepler-107 che contiene altri due pianeti di piccola taglia: Kepler-107d e Kepler-107e. Si tratta di un sistema planetario estremamente compatto perché le orbite dei suoi quattro pianeti sono vicine fra loro e tutte contenute dentro quella di Mercurio. I periodi orbitali dei pianeti b, c, d ed e, e cioè le durate del loro “anno”, sono rispettivamente pari a 3.2, 4.9, 8.0 e 14.7 giorni. Secondo modelli di dinamica planetaria, la configurazione orbitale dei pianeti implica che questi si siano formati molto più lontano dalla loro stella rispetto alle orbite attuali e siano successivamente migrati verso di essa. I quattro pianeti del sistema Kepler-107 erano già stati scoperti dal telescopio della NASA Kepler grazie all’osservazione dei loro transiti, ovvero delle diminuzioni di luce stellare durante il passaggio dei pianeti davanti alla stella, il che dà anche un’informazione sulla dimensione dei pianeti stessi.
(nell’immagine: rappresentazione artistica dell’impatto gigante sull’esopianeta Kepler-107c. L’immagine è stata riadattata partendo da quella realizzata da NASA/JPL-Caltech)

da Sorrentino | Gen 30, 2019 | Industria, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari
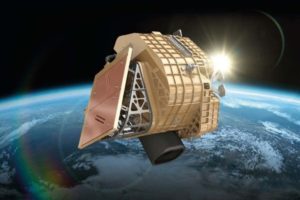 Si avvicina il lancio della missione PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il satellite verrà lanciato dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese la notte tra l’8 ed il 9 marzo prossimo, utilizzando il lanciatore VEGA dell’Agenzia Spaziale Europea di progettazione e costruzione italiana. Dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, PRISMA guarderà la Terra su scala globale con occhi diversi essendo dotato di una innovativa strumentazione elettro-ottica. Il satellite italiano osserverà il pianeta con lo strumento iperspettrale operativo più potente al mondo, in grado di lavorare in numerose, strette e contigue bande disposte dal visibile al vicino infrarosso (VNIR, Visible and Near InfraRed) e fino all’infrarosso ad onde corte (SWIR, Short Wave InfraRed).
Si avvicina il lancio della missione PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il satellite verrà lanciato dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese la notte tra l’8 ed il 9 marzo prossimo, utilizzando il lanciatore VEGA dell’Agenzia Spaziale Europea di progettazione e costruzione italiana. Dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, PRISMA guarderà la Terra su scala globale con occhi diversi essendo dotato di una innovativa strumentazione elettro-ottica. Il satellite italiano osserverà il pianeta con lo strumento iperspettrale operativo più potente al mondo, in grado di lavorare in numerose, strette e contigue bande disposte dal visibile al vicino infrarosso (VNIR, Visible and Near InfraRed) e fino all’infrarosso ad onde corte (SWIR, Short Wave InfraRed).
Il satellite PRISMA è un progetto dell’ASI e rappresenta un’eccellenza a livello globale, che mette in luce le capacità del nostro Paese di fornire un sistema spaziale chiavi in mano, dalla progettazione alla realizzazione, dal lancio alla gestione dei dati a terra. PRISMA è stato realizzato da un RTI, Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica. A definire ancor meglio il profilo nazionale è il lancio che avverrà con il vettore VEGA prodotto da AVIO, lanciatore dell’ESA ma di concezione e costruzione a prevalenza italiana. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l’acquisizione e l’elaborazione dei dati avverrà dal Centro Spaziale di Matera. La missione potrà dare un contributo senza precedenti all’osservazione dallo spazio delle risorse naturali e allo studio dei principali processi ambientali (es. interazioni tra atmosfera, biosfera e idrosfera; osservazione dei cambiamenti dell’ambiente e del clima a livello globale; effetti delle attività antropiche sugli ecosistemi). Nell’ambito applicativo, PRISMA sarà in grado di fornire preziose informazioni a supporto delle opere di prevenzione rispetto ai rischi naturali (come quello idrogeologico) ed antropici (tra cui l’inquinamento del suolo), del monitoraggio dei beni culturali, delle azioni di ausilio alle crisi umanitarie, delle attività agricole e di sfruttamento delle risorse minerarie. A differenza dei sensori ottici passivi satellitari attualmente operativi, che registrano la radiazione solare riflessa dal nostro pianeta in un numero limitato di bande spettrali – tipicamente al massimo una decina – la strumentazione a bordo del satellite PRISMA è infatti in grado di acquisirne 240 (239 bande spettrali più il canale pancromatico); ciò permetterà di raffinare le conoscenze riguardanti le risorse naturali ed i principali processi ambientali in atto, come i fenomeni legati al cambiamento climatico. La tecnologia iperspettrale permette, infatti, di vedere più dell’occhio umano e di riconoscere non solo le forme degli oggetti ma anche quali elementi chimici contengono. Ogni materiale ha una propria firma spettrale, una vera impronta digitale: una combinazione unica di colori, detti bande spettrali. Lo strumento di PRISMA sarà in grado di analizzare questa firma viaggiando a 27.000 km all’ora, e potrà così identificare un oggetto o risalire alle caratteristiche di un’area sotto osservazione.

da Sorrentino | Gen 25, 2019 | Astronomia, Primo Piano
 Il cacciatore di pianeti SPHERE, montato in uno dei telescopi del VLT (Very Large Telescope) in Cile, ha analizzato il disco ricco di gas scoprendo la presenza di un oggetto che potrebbe essere un protopianeta, osservando le immagini ad alto contrasto e alta risoluzione dei dintorni della giovane stella HD169142. Il disco osservato e studiato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, guidato dall’astronomo Raffaele Gratton, è formato da tre anelli e all’interno di una delle cavità vi sono sia bracci di spirale che addensamenti di polvere. Le spirali possono essere causate dalla presenza di un pianeta. Secondo i ricercatori, questo oggetto si troverebbe lungo il braccio principale e presumibilmente nella cavità tra il secondo e il terzo anello. I pianeti si formano nei dischi protostellari, durante lo stesso evento che porta alla formazione della stella. L’osservazione di pianeti appena formati fornisce informazioni chiave sui dettagli del meccanismo di formazione. Ci si aspetta che i pianeti giovani causino cavità e spirali nei dischi. Tuttavia, i pianeti più giovani sono circondati da nubi di polvere che ne rendono difficile l’osservazione diretta e quindi la conferma della loro presenza. Per questo motivo, vi sono pochissime rivelazioni chiare di pianeti in una simile fase evolutiva, in dischi ancora ricchi di gas; un caso particolarmente interessante riguarda l’ambiente attorno alla stella PDS70, recentemente scrutato sempre da SPHERE. Mentre molti degli addensamenti di polvere sono all’interno degli anelli del disco della stella HD169142, uno si trova nella cavità tra i due anelli esterni. Numerosi aspetti del sistema trovano una ragionevole spiegazione se si assume che quell’addensamento sia una nube che avvolge il pianeta ritenuto responsabile delle spirali e della cavità osservate da SPHERE. Il pianeta non è visibile alle lunghezze d’onda più corte, dove si vede solo la nube che lo circonda illuminata dalla stella, ma potrebbe essere responsabile di quello che si vede alle lunghezze d’onda più lunghe (oltre 2 micron). È possibile stimare una massa usando dati dinamici e fotometri: il risultato è tra 1 e 4 volte la massa di Giove.
Il cacciatore di pianeti SPHERE, montato in uno dei telescopi del VLT (Very Large Telescope) in Cile, ha analizzato il disco ricco di gas scoprendo la presenza di un oggetto che potrebbe essere un protopianeta, osservando le immagini ad alto contrasto e alta risoluzione dei dintorni della giovane stella HD169142. Il disco osservato e studiato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, guidato dall’astronomo Raffaele Gratton, è formato da tre anelli e all’interno di una delle cavità vi sono sia bracci di spirale che addensamenti di polvere. Le spirali possono essere causate dalla presenza di un pianeta. Secondo i ricercatori, questo oggetto si troverebbe lungo il braccio principale e presumibilmente nella cavità tra il secondo e il terzo anello. I pianeti si formano nei dischi protostellari, durante lo stesso evento che porta alla formazione della stella. L’osservazione di pianeti appena formati fornisce informazioni chiave sui dettagli del meccanismo di formazione. Ci si aspetta che i pianeti giovani causino cavità e spirali nei dischi. Tuttavia, i pianeti più giovani sono circondati da nubi di polvere che ne rendono difficile l’osservazione diretta e quindi la conferma della loro presenza. Per questo motivo, vi sono pochissime rivelazioni chiare di pianeti in una simile fase evolutiva, in dischi ancora ricchi di gas; un caso particolarmente interessante riguarda l’ambiente attorno alla stella PDS70, recentemente scrutato sempre da SPHERE. Mentre molti degli addensamenti di polvere sono all’interno degli anelli del disco della stella HD169142, uno si trova nella cavità tra i due anelli esterni. Numerosi aspetti del sistema trovano una ragionevole spiegazione se si assume che quell’addensamento sia una nube che avvolge il pianeta ritenuto responsabile delle spirali e della cavità osservate da SPHERE. Il pianeta non è visibile alle lunghezze d’onda più corte, dove si vede solo la nube che lo circonda illuminata dalla stella, ma potrebbe essere responsabile di quello che si vede alle lunghezze d’onda più lunghe (oltre 2 micron). È possibile stimare una massa usando dati dinamici e fotometri: il risultato è tra 1 e 4 volte la massa di Giove.

da Sorrentino | Gen 24, 2019 | Astronomia, Primo Piano
 Attorno a una stella in formazione di taglia simile al nostro Sole, scoperta da un team internazionale di scienziati, tra cui Víctor M. Rivilla dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, la molecola organica HOCH2CN, un precursore chiave nel processo di assemblaggio dei “mattoni” di RNA e DNA. E’ la prima volta che viene individuata l’esistenza di molecole prebiotiche di glicolonitrile (HOCH2CN) nello spazio, per la precisione nel materiale che circonda la stella in formazione IRAS16293-2422 B, distante circa 450 anni luce da noi. La scoperta, importante per lo studio delle molecole di DNA e RNA nello spazio, è stata realizzata grazie ai dati raccolti dalle antenne di ALMA in Cile ed è stata appena pubblicata sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Tra gli autori figurano anche Víctor M. Rivilla, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Arcetri a Firenze, e Leonardo Testi, astronomo dell’ESO e associato INAF. Tra le numerose teorie che ritengono l’RNA primordiale alla base della vita come la conosciamo, la molecola di glicolonitrile è riconosciuta come un precursore chiave nei processi che portano alla formazione delle basi azotate, come ad esempio l’adenina (una delle componenti fondamentali delle catene di RNA e DNA). Ricordiamo che un team di ricercatori guidato da RiVilla ha scoperto di recente anche un altro precursore di questo nucleotide, la cianometanimina, all’interno di una nube molecolare nella nostra galassia.
Attorno a una stella in formazione di taglia simile al nostro Sole, scoperta da un team internazionale di scienziati, tra cui Víctor M. Rivilla dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, la molecola organica HOCH2CN, un precursore chiave nel processo di assemblaggio dei “mattoni” di RNA e DNA. E’ la prima volta che viene individuata l’esistenza di molecole prebiotiche di glicolonitrile (HOCH2CN) nello spazio, per la precisione nel materiale che circonda la stella in formazione IRAS16293-2422 B, distante circa 450 anni luce da noi. La scoperta, importante per lo studio delle molecole di DNA e RNA nello spazio, è stata realizzata grazie ai dati raccolti dalle antenne di ALMA in Cile ed è stata appena pubblicata sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Tra gli autori figurano anche Víctor M. Rivilla, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Arcetri a Firenze, e Leonardo Testi, astronomo dell’ESO e associato INAF. Tra le numerose teorie che ritengono l’RNA primordiale alla base della vita come la conosciamo, la molecola di glicolonitrile è riconosciuta come un precursore chiave nei processi che portano alla formazione delle basi azotate, come ad esempio l’adenina (una delle componenti fondamentali delle catene di RNA e DNA). Ricordiamo che un team di ricercatori guidato da RiVilla ha scoperto di recente anche un altro precursore di questo nucleotide, la cianometanimina, all’interno di una nube molecolare nella nostra galassia.
“La nostra scoperta – afferma Rivilla è un nuovo passo avanti nella ricerca della vita nello spazio. Il glicolonitrile infatti è una molecola molto interessante dal punto di vista astrobiologico perché è considerata un ingrediente chiave per formare alcuni “mattoni” fondamentali della vita, come i nucleotidi dell’RNA e DNA, e anche aminoacidi come la glicina, presente in molte proteine”. La protostella in prossimità della quale è stato individuato il glicolonitrile si trova a 450 anni luce dalla Terra in direzione della costellazione di Ofiuco, all’interno della regione denominata Rho Ophiuchi, ricca di giovani stelle nelle prime fasi della loro evoluzione, circondate da un bozzolo di polvere e gas – condizioni simili a quelle in cui si formò il nostro Sistema solare. Rilevare le molecole prebiotiche nelle protostelle di tipo solare aiuta i ricercatori a comprendere meglio la formazione del nostro sistema planetario e in generale i processi che possono innescare l’insorgenza di forme elementari di vita nello spazio.
Nella stessa zona di formazione stellare, più di un anno e mezzo fa, un altro gruppo di ricercatori, che vedeva coinvolti anche i ricercatori dell’INAF, ha trovato tracce di isocianato di metile attorno a stelle simili al Sole in una fase precoce della loro formazione. Si tratta di una delle molecole complesse alla base della vita, ma è anche un isomero del glicolonitrile (cioè è composto dagli stessi atomi ma disposti in maniera leggermente diversa). I dati di ALMA sono stati fondamentali per identificare le firme chimiche del glicolonitrile e per determinare le condizioni in cui è stata trovata la molecola.



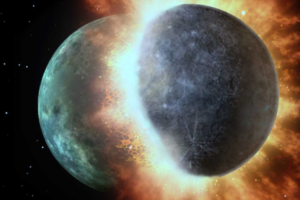 Hanno più o meno la stessa dimensione, circa una volta e mezza il raggio della Terra, ma una eccezionale diversità nella densità media e dunque nella composizione chimica. Sono gli esopianeti Kepler-107b e Kepler-107c, due super-terre calde che hanno masse rispettivamente di circa tre e nove masse terresti e orbitano attorno alla loro stella a distanze molto ravvicinate da essa: 6,7 e 9 milioni di chilometri rispettivamente, cioè il 4,5% e il 6% della distanza Terra-Sole. A caratterizzarle è stato un team internazionale di ricercatori guidati da Aldo Bonomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) a Torino, grazie ai dati raccolti dallo spettrografo HARPS-N installato al Telescopio Nazionale Galileo sulle Isole Canarie. Lo studio ha mostrato che la super-terra più massiva e densa Kepler-107c contiene nel suo nucleo una frazione in massa di ferro che è almeno il doppio della sua “gemella” Kepler-107b. Tale diversità in composizione può essere spiegata ipotizzando che la super-terra Kepler-107c, poco dopo la sua formazione, abbia subìto un impatto frontale ad elevata velocità con un protopianeta della stessa massa o più collisioni con protopianeti di massa inferiore. Questi impatti avrebbero squarciato il suo mantello roccioso di silicati (composti del silicio, ossigeno e magnesio o altri metalli) riducendone l’abbondanza rispetto al ferro e rendendo così la super-terra Kepler-107c più densa.
Hanno più o meno la stessa dimensione, circa una volta e mezza il raggio della Terra, ma una eccezionale diversità nella densità media e dunque nella composizione chimica. Sono gli esopianeti Kepler-107b e Kepler-107c, due super-terre calde che hanno masse rispettivamente di circa tre e nove masse terresti e orbitano attorno alla loro stella a distanze molto ravvicinate da essa: 6,7 e 9 milioni di chilometri rispettivamente, cioè il 4,5% e il 6% della distanza Terra-Sole. A caratterizzarle è stato un team internazionale di ricercatori guidati da Aldo Bonomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) a Torino, grazie ai dati raccolti dallo spettrografo HARPS-N installato al Telescopio Nazionale Galileo sulle Isole Canarie. Lo studio ha mostrato che la super-terra più massiva e densa Kepler-107c contiene nel suo nucleo una frazione in massa di ferro che è almeno il doppio della sua “gemella” Kepler-107b. Tale diversità in composizione può essere spiegata ipotizzando che la super-terra Kepler-107c, poco dopo la sua formazione, abbia subìto un impatto frontale ad elevata velocità con un protopianeta della stessa massa o più collisioni con protopianeti di massa inferiore. Questi impatti avrebbero squarciato il suo mantello roccioso di silicati (composti del silicio, ossigeno e magnesio o altri metalli) riducendone l’abbondanza rispetto al ferro e rendendo così la super-terra Kepler-107c più densa.
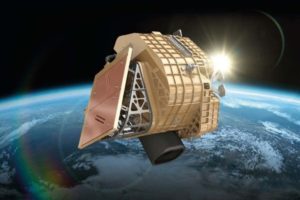 Si avvicina il lancio della missione PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il satellite verrà lanciato dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese la notte tra l’8 ed il 9 marzo prossimo, utilizzando il lanciatore VEGA dell’Agenzia Spaziale Europea di progettazione e costruzione italiana. Dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, PRISMA guarderà la Terra su scala globale con occhi diversi essendo dotato di una innovativa strumentazione elettro-ottica. Il satellite italiano osserverà il pianeta con lo strumento iperspettrale operativo più potente al mondo, in grado di lavorare in numerose, strette e contigue bande disposte dal visibile al vicino infrarosso (VNIR, Visible and Near InfraRed) e fino all’infrarosso ad onde corte (SWIR, Short Wave InfraRed).
Si avvicina il lancio della missione PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il satellite verrà lanciato dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese la notte tra l’8 ed il 9 marzo prossimo, utilizzando il lanciatore VEGA dell’Agenzia Spaziale Europea di progettazione e costruzione italiana. Dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, PRISMA guarderà la Terra su scala globale con occhi diversi essendo dotato di una innovativa strumentazione elettro-ottica. Il satellite italiano osserverà il pianeta con lo strumento iperspettrale operativo più potente al mondo, in grado di lavorare in numerose, strette e contigue bande disposte dal visibile al vicino infrarosso (VNIR, Visible and Near InfraRed) e fino all’infrarosso ad onde corte (SWIR, Short Wave InfraRed).
 Il cacciatore di pianeti SPHERE, montato in uno dei telescopi del VLT (Very Large Telescope) in Cile, ha analizzato il disco ricco di gas scoprendo la presenza di un oggetto che potrebbe essere un protopianeta, osservando le immagini ad alto contrasto e alta risoluzione dei dintorni della giovane stella HD169142. Il disco osservato e studiato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, guidato dall’astronomo Raffaele Gratton, è formato da tre anelli e all’interno di una delle cavità vi sono sia bracci di spirale che addensamenti di polvere. Le spirali possono essere causate dalla presenza di un pianeta. Secondo i ricercatori, questo oggetto si troverebbe lungo il braccio principale e presumibilmente nella cavità tra il secondo e il terzo anello. I pianeti si formano nei dischi protostellari, durante lo stesso evento che porta alla formazione della stella. L’osservazione di pianeti appena formati fornisce informazioni chiave sui dettagli del meccanismo di formazione. Ci si aspetta che i pianeti giovani causino cavità e spirali nei dischi. Tuttavia, i pianeti più giovani sono circondati da nubi di polvere che ne rendono difficile l’osservazione diretta e quindi la conferma della loro presenza. Per questo motivo, vi sono pochissime rivelazioni chiare di pianeti in una simile fase evolutiva, in dischi ancora ricchi di gas; un caso particolarmente interessante riguarda l’ambiente attorno alla stella PDS70, recentemente scrutato sempre da SPHERE. Mentre molti degli addensamenti di polvere sono all’interno degli anelli del disco della stella HD169142, uno si trova nella cavità tra i due anelli esterni. Numerosi aspetti del sistema trovano una ragionevole spiegazione se si assume che quell’addensamento sia una nube che avvolge il pianeta ritenuto responsabile delle spirali e della cavità osservate da SPHERE. Il pianeta non è visibile alle lunghezze d’onda più corte, dove si vede solo la nube che lo circonda illuminata dalla stella, ma potrebbe essere responsabile di quello che si vede alle lunghezze d’onda più lunghe (oltre 2 micron). È possibile stimare una massa usando dati dinamici e fotometri: il risultato è tra 1 e 4 volte la massa di Giove.
Il cacciatore di pianeti SPHERE, montato in uno dei telescopi del VLT (Very Large Telescope) in Cile, ha analizzato il disco ricco di gas scoprendo la presenza di un oggetto che potrebbe essere un protopianeta, osservando le immagini ad alto contrasto e alta risoluzione dei dintorni della giovane stella HD169142. Il disco osservato e studiato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, guidato dall’astronomo Raffaele Gratton, è formato da tre anelli e all’interno di una delle cavità vi sono sia bracci di spirale che addensamenti di polvere. Le spirali possono essere causate dalla presenza di un pianeta. Secondo i ricercatori, questo oggetto si troverebbe lungo il braccio principale e presumibilmente nella cavità tra il secondo e il terzo anello. I pianeti si formano nei dischi protostellari, durante lo stesso evento che porta alla formazione della stella. L’osservazione di pianeti appena formati fornisce informazioni chiave sui dettagli del meccanismo di formazione. Ci si aspetta che i pianeti giovani causino cavità e spirali nei dischi. Tuttavia, i pianeti più giovani sono circondati da nubi di polvere che ne rendono difficile l’osservazione diretta e quindi la conferma della loro presenza. Per questo motivo, vi sono pochissime rivelazioni chiare di pianeti in una simile fase evolutiva, in dischi ancora ricchi di gas; un caso particolarmente interessante riguarda l’ambiente attorno alla stella PDS70, recentemente scrutato sempre da SPHERE. Mentre molti degli addensamenti di polvere sono all’interno degli anelli del disco della stella HD169142, uno si trova nella cavità tra i due anelli esterni. Numerosi aspetti del sistema trovano una ragionevole spiegazione se si assume che quell’addensamento sia una nube che avvolge il pianeta ritenuto responsabile delle spirali e della cavità osservate da SPHERE. Il pianeta non è visibile alle lunghezze d’onda più corte, dove si vede solo la nube che lo circonda illuminata dalla stella, ma potrebbe essere responsabile di quello che si vede alle lunghezze d’onda più lunghe (oltre 2 micron). È possibile stimare una massa usando dati dinamici e fotometri: il risultato è tra 1 e 4 volte la massa di Giove.
 Attorno a una stella in formazione di taglia simile al nostro Sole, scoperta da un team internazionale di scienziati, tra cui Víctor M. Rivilla dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, la molecola organica HOCH2CN, un precursore chiave nel processo di assemblaggio dei “mattoni” di RNA e DNA. E’ la prima volta che viene individuata l’esistenza di molecole prebiotiche di glicolonitrile (HOCH2CN) nello spazio, per la precisione nel materiale che circonda la stella in formazione IRAS16293-2422 B, distante circa 450 anni luce da noi. La scoperta, importante per lo studio delle molecole di DNA e RNA nello spazio, è stata realizzata grazie ai dati raccolti dalle antenne di ALMA in Cile ed è stata appena pubblicata sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Tra gli autori figurano anche Víctor M. Rivilla, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Arcetri a Firenze, e Leonardo Testi, astronomo dell’ESO e associato INAF. Tra le numerose teorie che ritengono l’RNA primordiale alla base della vita come la conosciamo, la molecola di glicolonitrile è riconosciuta come un precursore chiave nei processi che portano alla formazione delle basi azotate, come ad esempio l’adenina (una delle componenti fondamentali delle catene di RNA e DNA). Ricordiamo che un team di ricercatori guidato da RiVilla ha scoperto di recente anche un altro precursore di questo nucleotide, la cianometanimina, all’interno di una nube molecolare nella nostra galassia.
Attorno a una stella in formazione di taglia simile al nostro Sole, scoperta da un team internazionale di scienziati, tra cui Víctor M. Rivilla dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, la molecola organica HOCH2CN, un precursore chiave nel processo di assemblaggio dei “mattoni” di RNA e DNA. E’ la prima volta che viene individuata l’esistenza di molecole prebiotiche di glicolonitrile (HOCH2CN) nello spazio, per la precisione nel materiale che circonda la stella in formazione IRAS16293-2422 B, distante circa 450 anni luce da noi. La scoperta, importante per lo studio delle molecole di DNA e RNA nello spazio, è stata realizzata grazie ai dati raccolti dalle antenne di ALMA in Cile ed è stata appena pubblicata sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Tra gli autori figurano anche Víctor M. Rivilla, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Arcetri a Firenze, e Leonardo Testi, astronomo dell’ESO e associato INAF. Tra le numerose teorie che ritengono l’RNA primordiale alla base della vita come la conosciamo, la molecola di glicolonitrile è riconosciuta come un precursore chiave nei processi che portano alla formazione delle basi azotate, come ad esempio l’adenina (una delle componenti fondamentali delle catene di RNA e DNA). Ricordiamo che un team di ricercatori guidato da RiVilla ha scoperto di recente anche un altro precursore di questo nucleotide, la cianometanimina, all’interno di una nube molecolare nella nostra galassia.








