
da Sorrentino | Feb 8, 2017 | Eventi, Politica Spaziale, Primo Piano
 Il valore della Space Economy in Italia può essere bene rappresentato da pochi ma essenziali numeri: un peso occupazionale di 6.000 addetti, un fatturato da 1,6 miliardi di euro, ulteriori fond per 500 milioni nel 2016 di cui 360 stanziati dal Cipe e 140 milioni dalle Regioni, che metteranno in moto un miliardo di euro di investimenti per le industrie con tempi di assegnazione agli inizi dell’autunno 2017. E per comprendere quanto le attività spaziali incidano sulla crescita economica del nostro Paese e fungano da motore della ricerca scientifica, basta ricordare che ogni euro investito ne genera da 3 a 5 in altri settori. Un quadro delineato nel corso di un convegno promosso da Air Press al Centro Studi Americani di Roma, con la partecipazione dei titolari dei dicasteri dello Sviluppo Economico e del Miur insieme ai principali attori nazionali dello Spazio, e servito a fare il punto su strategie e potenzialità dell’Italia che, nel comparto specifico, restano alte ma necessitano di maggiori sinergie. Su questo punto, infatti, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ha rimarcato la necessità di fare sistema per aumentare la competitività del nostro Paese, che pure riveste un ruolo di assoluta eccellenza sia a livello europeo che internazionale. Ma c’è ampio margine di crescita e per allargare il fronte delle collaborazioni. E a tale proposito, sia il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che quello dell’Istruzione e della Ricerca, Valeria Fedeli, hanno confermato l’intenzione di tramutare la cabina di regia dello Spazio promossa nel 2016 in un Comitato interministeriale per lo Spazio.
Il valore della Space Economy in Italia può essere bene rappresentato da pochi ma essenziali numeri: un peso occupazionale di 6.000 addetti, un fatturato da 1,6 miliardi di euro, ulteriori fond per 500 milioni nel 2016 di cui 360 stanziati dal Cipe e 140 milioni dalle Regioni, che metteranno in moto un miliardo di euro di investimenti per le industrie con tempi di assegnazione agli inizi dell’autunno 2017. E per comprendere quanto le attività spaziali incidano sulla crescita economica del nostro Paese e fungano da motore della ricerca scientifica, basta ricordare che ogni euro investito ne genera da 3 a 5 in altri settori. Un quadro delineato nel corso di un convegno promosso da Air Press al Centro Studi Americani di Roma, con la partecipazione dei titolari dei dicasteri dello Sviluppo Economico e del Miur insieme ai principali attori nazionali dello Spazio, e servito a fare il punto su strategie e potenzialità dell’Italia che, nel comparto specifico, restano alte ma necessitano di maggiori sinergie. Su questo punto, infatti, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ha rimarcato la necessità di fare sistema per aumentare la competitività del nostro Paese, che pure riveste un ruolo di assoluta eccellenza sia a livello europeo che internazionale. Ma c’è ampio margine di crescita e per allargare il fronte delle collaborazioni. E a tale proposito, sia il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che quello dell’Istruzione e della Ricerca, Valeria Fedeli, hanno confermato l’intenzione di tramutare la cabina di regia dello Spazio promossa nel 2016 in un Comitato interministeriale per lo Spazio.
Ma la sfida non è solo tra soggetti governativi, come ha sottolineato Battiston, ma sempre più con i privati che hanno lanciato la propria sfida ai servizi spaziali. Il riferimento è alla SpaceX di Elon Musk e alla Virgin Galactic di Richard Branson, ma anche alla Planet capace di mettere in orbita 80 satelliti, per un valore corrispondente di 30mila euro cadauno, e generare immagini utili per il controllo dell’ambiente. Una competizione aperta, alla quale non si sottrae Giulio Ranzo, Ceo di Avio, che sta commercializzando i lanci del razzo Vega, il lanciatore europeo dal cuore italiano realizzato negli stabilimenti di Colleferro. “La quotazione in Borsa di Avio – sostiene Ranzo – è una buona notizia, ci consentirà di competere sul mercato anche con investimenti privati”. Il gioco si basa prima sul prezzo e l’affidabilità, quindi sull’accuratezza con cui si posizionano in orbita i satelliti: Google ha scelto noi, e non un razzo Usa, per portare nello spazio i suoi mini satelliti SkySat”. Dallo spazio, ricorda Ranzo, “si possono monitorare le fabbriche e la loro produzione, i campi profughi, le navi in mezzo al mare, i container carichi di merci. Dallo spazio ora possiamo ricevere il segnale per collegarci a Internet come fosse il wi-fi di casa”.
 Lapidario Luigi Pasquali, ad di Telespazio e direttore del settore Spazio di Leonardo Finmeccanica, nell’osservare come per anni sia stata data una spinta importante allo sviluppo di tecnologie innovative per lo spazio, ma ora sia arrivato il momento di fornire la spinta a usarle. “Ora diventiamo consumatori, cioè produciamo sviluppo e noi come Telespazio sviluppiamo servizi dallo spazio”. Pasquali rimarca anche il ruolo dell`Italia, che si inserisce in una più ampia cornice europea come testimoniano i numerosi programmi congiunti. “L’avvio di una strategia spaziale comune, come testimoniato da programmi come Galileo, Copernicus ed Egnos, segna un passaggio epocale e la disponibilità del governo ad iniettare risorse è un aspetto fondamentale per lo sviluppo della space economy. C’è bisogno di una pianificazione nazionale che si affianchi alle strategie dei soggetti privati”.
Lapidario Luigi Pasquali, ad di Telespazio e direttore del settore Spazio di Leonardo Finmeccanica, nell’osservare come per anni sia stata data una spinta importante allo sviluppo di tecnologie innovative per lo spazio, ma ora sia arrivato il momento di fornire la spinta a usarle. “Ora diventiamo consumatori, cioè produciamo sviluppo e noi come Telespazio sviluppiamo servizi dallo spazio”. Pasquali rimarca anche il ruolo dell`Italia, che si inserisce in una più ampia cornice europea come testimoniano i numerosi programmi congiunti. “L’avvio di una strategia spaziale comune, come testimoniato da programmi come Galileo, Copernicus ed Egnos, segna un passaggio epocale e la disponibilità del governo ad iniettare risorse è un aspetto fondamentale per lo sviluppo della space economy. C’è bisogno di una pianificazione nazionale che si affianchi alle strategie dei soggetti privati”.
La Cabina di regia di Palazzo Chigi, ha assicurato il coordinatore Paolo Puri, “ha colto il segnale che veniva dalle industrie”. “Fare sistema? Io ci ho provato e l’ho fatto e la risposta è stata positiva” ha assicurato Puri dell’Autorità nazionale responsabile per il Prs del programma Galileo. Di tempi e velocità di azione ha infine parlato il Ceo di Thales Alenia Space Italia, Donato Amoroso: “Rispetto ai visionari come Musk e Branson che rompono gli schemi, abbiamo una certa inerzia”. “La competizione si sta allargando, dobbiamo avere una visione di prospettiva e, dunque, accelerare”. Infine l’accento posto dal ministro Calenda sulla spinta che il lavoro comune in Europa su Spazio e Difesa può rappresentare per la crescita dell`Europa.

da Sorrentino | Gen 25, 2017 | Eventi, Politica Spaziale, Primo Piano
 I Paesi dell’Unione Europea si sono ritrovati a Bruxelles per discutere la strada da seguire in tema di programmi e strategie spaziali e delle relative opportunità il settore offre per lo sviluppo delle attività tecnologiche avanzate a ogni singolo Paese. L’occasione è stata la nona Conferenza sulla European Space Policy, che ha ripreso i contenuti della Comunicazione prodotta dalla Commissione Europea sulla Strategia Spaziale per l’Europa, pubblicata lo scorso 26 ottobre. Un confronto che ha coinvolto i rappresentanti di Parlamento e Commissione Europei, dell’Agenzia Spaziale Europea e delle Agenzie Spaziali nazionali.
I Paesi dell’Unione Europea si sono ritrovati a Bruxelles per discutere la strada da seguire in tema di programmi e strategie spaziali e delle relative opportunità il settore offre per lo sviluppo delle attività tecnologiche avanzate a ogni singolo Paese. L’occasione è stata la nona Conferenza sulla European Space Policy, che ha ripreso i contenuti della Comunicazione prodotta dalla Commissione Europea sulla Strategia Spaziale per l’Europa, pubblicata lo scorso 26 ottobre. Un confronto che ha coinvolto i rappresentanti di Parlamento e Commissione Europei, dell’Agenzia Spaziale Europea e delle Agenzie Spaziali nazionali.
A partire dall’intervento di Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la quale ha sottolineato come l’UE abbia i requisiti e le potenzialità per essere una potenza spaziale, proprio grazie all’eccellenza e alle competenze raggiunte dalle industrie europee nel settore spaziale. Un preciso indirizzo delle strategie è stato tracciato da Roberto Battiston, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, secondo il quale lo spazio appartiene non solo a chi costruisce gli asset spaziali ma anche a chi li utilizza. “Lo spazio dà all’Europa un’opportunità unica: la possibilità di usarlo come strumento per le politiche globali e per la diplomazia” – ha affermato Battiston, richiamando la necessità che l’Europa lavori insieme per sviluppare nuove tecnologie, idonee a rispondere alle esigenze che si manifestano di volta in volta, e investire in educazione e comunicazione, in quanto queste favoriscono ad un tempo la crescita dell’individuo e la diffusione dell’informazione verso il cittadino europeo.
“La strategia spaziale europea annunciata nel 2016 dalla Commissione Europea costituisce la premessa per un solido sviluppo delle attività spaziali nel nostro continente – ha dichiarato Luigi Pasquali, direttore del Settore Spazio di Leonardo e CEO di Telespazio, nel corso del suo intervento al meeting – L’industria europea è stata chiamata a contribuire alla definizione della Strategia, vedendo così pienamente riconosciuto il proprio ruolo di stakeholder”.
“Ci aspettiamo che questo avvenga anche nella fase della delivery della strategia stessa – ha concluso Pasquali – In questo quadro Leonardo, con la sua ampia gamma di attività in ambito spaziale, rappresenta uno dei player di riferimento in Europa, ed è in grado di cogliere in modo efficace le opportunità offerte sia dallo sviluppo della Space Economy che dalle nuove tendenze tecnologiche e dai nuovi modelli di business che stanno emergendo nel quadro del cosiddetto New Space”.

da Sorrentino | Gen 18, 2017 | Eventi, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi
 La tradizionale conferenza stampa di inizio anno del direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, indetta per presentare i programmi e i principali appuntamenti del 2017, ha rivelato un problema, per il momento senza conseguenze operative, agli orologi dei 18 satelliti attualmente in orbita del sistema di navigazione Galileo. Jan Woerner ha spiegato che, dopo l’avvio dell’avvio della fase operativa sperimentale del Gps europeo avvenuto il 15 dicembre 2016 con 18 dei 30 satelliti destinati a formare la costellazione completa, nove dei 72 orologi di altissima precisione attualmente a bordo delle singole piattaforme hanno manifestato malfunzionamento. Ogni satellite ha una dotazione di quattro orologi, due al rubidio e due maser all’idrogeno. Si è riscontrato che quelli che non rispondono ai requisiti nominali sono sei maser a idrogeno passivo e tre orologi atomici al rubidio. Fortunatamente, perché un satellite svolga appieno la sua missione è sufficiente che almeno due dei quattro orologi atomici funzioni. Il che vuol dire che il programma Galileo è salvo, ma occorre risalire rapidamente alla causa del problema e individuare le soluzioni idonee a verificare che i prossimi 48 orologi a bordo della dozzina di satelliti mancanti funzionino regolarmente. Ciò per scongiurare ulteriore ritardi nel programma dei lanci, il prossimo dei quali è in calendario il 9 agosto dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese quando è previsto che un razzo Ariane 5 trasferisca in orbita quattro satelliti Galileo.
La tradizionale conferenza stampa di inizio anno del direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, indetta per presentare i programmi e i principali appuntamenti del 2017, ha rivelato un problema, per il momento senza conseguenze operative, agli orologi dei 18 satelliti attualmente in orbita del sistema di navigazione Galileo. Jan Woerner ha spiegato che, dopo l’avvio dell’avvio della fase operativa sperimentale del Gps europeo avvenuto il 15 dicembre 2016 con 18 dei 30 satelliti destinati a formare la costellazione completa, nove dei 72 orologi di altissima precisione attualmente a bordo delle singole piattaforme hanno manifestato malfunzionamento. Ogni satellite ha una dotazione di quattro orologi, due al rubidio e due maser all’idrogeno. Si è riscontrato che quelli che non rispondono ai requisiti nominali sono sei maser a idrogeno passivo e tre orologi atomici al rubidio. Fortunatamente, perché un satellite svolga appieno la sua missione è sufficiente che almeno due dei quattro orologi atomici funzioni. Il che vuol dire che il programma Galileo è salvo, ma occorre risalire rapidamente alla causa del problema e individuare le soluzioni idonee a verificare che i prossimi 48 orologi a bordo della dozzina di satelliti mancanti funzionino regolarmente. Ciò per scongiurare ulteriore ritardi nel programma dei lanci, il prossimo dei quali è in calendario il 9 agosto dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese quando è previsto che un razzo Ariane 5 trasferisca in orbita quattro satelliti Galileo.
Restando ai programmi in orbita terreste, Woerner ha ricordato la partenza il 28 gennaio di SmallGEO, la nuova piccola versatile piattaforma geostazionaria d’Europa, che sarà lanciata per la sua prima missione come satellite di telecomunicazione Hispasat 36W-1. A seguire, il secondo satellite Sentinel-2B facente parte della costellazione Copernicus per l’Osservazione del territorio europeo, che sarà messo in orbita il 7 marzo da un lanciatore Vega. Nel mese di giugno toccherà a Sentinel-5P, sviluppato in collaborazione con il Netherlands Space Office, che sarà lanciato a bordo di un razzo Rockot dal cosmodromo russo di Plesetsk.
Nel mese di ottobre Ariane 5 porterà in orbita il secondo nodo del Sistema Europeo di Trasmissione Dati, EDRS-C, che permetterà il trasferimento di dati al suolo in quasi tempo reale dai satelliti in orbita bassa utilizzando una tecnologia laser all’avanguardia. A fine anno in programma il lancio a bordo di un razzo Vega dalla Guyana Francese di ADM-Aeolus, il primo satellite in assoluto a fornire profili del vento su scala globale e su base giornaliera.
Woerner si è soffermato sulla missione Exomars, ricordando che, dopo lo schianto della sonda Schiaparelli nella fase di discesa su Marte, la sonda Trace Gas Orbiter sta svolgendo la sua missione intorno al Pianeta Rosso in attesa dell’arrivo del rover europeo con la missione 2020.
Dopo il rientro di Thomas Pesquet il 15 maggio, al termine dei sei mesi di permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale per la missione Proxima, il 29 maggio toccherà a Paolo Nespoli dare inizio alla missione di lunga durata Vita. Per la seconda metà del 2017 è prevista l’apertura al centro addestramento di Colonia in Germania della Lunar analogue facility, una nuova struttura per le prove e per far familiarizzare gli astronauti con un ambiente simile a quello lunare.

da Sorrentino | Dic 30, 2016 | Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Recensioni

Ryan Gosling e Neil Armstrong
La vita di Neil Armstrong, l’uomo che per primo mise piede sulla Luna il 20 luglio 1969, raccontata in un film, le cui riprese partiranno agli inizi del 2017. Si intitolerà “First Man”, sarà diretto da Damien Chazelle e vedrà Ryan Gosling nel ruolo del celebre astronauta. A sceneggiarlo è stato Josh Singer, premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale di Spotlight, il quale si è ispirato alla biografia scritta da James Hansen e intitolata “First Man: A Life Of Neil A. Armstrong”.
Armstrong, nato e vissuto in Ohio, fu pilota di jet della marina militare durante la guerra di Corea portando a termine 72 missioni, si laureò in ingegneria aeronautica e fu pilota collaudatore dell’aereo X-15 della NASA prima di essere selezionato come astronauta nel 1962. Il film si concentrerà proprio sul programma spaziale americano, che vide Armstrong in orbita nel 1966 quale comandante della missione Gemini 8, la prima culminata con l’aggancio di due veicoli e che ebbe successo grazie alla sua abilità nel risolvere una complicata situazione provocata dal malfunzionamento di uno dei propulsori utilizzati per la manovra orbitale. Dopo essere stato comandante dell’equipaggio di riserva nella missione Apollo 8, la prima a raggiungere la Luna nel Natale 1968, Armstrong comandò la missione Apollo 11 culminata con il primo allunaggio. Fu proprio lui, durante le ultime fasi della discesa, a decidere di pilotare manualmente il modulo lunare Eagle consentendo di posarsi in una zona pianeggiante e idonea. Alle sue prime parole, “Houston, qui Base della Tranquillità. L’Aquila è atterrata”, seguì sette ore più tardi la frase storica “”Questo è un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità”, pronunciata al momento di lasciare la prima impronta sul suolo lunare.
Dopo essere diventato “The First Man on the Moon”, Armstrong lasciò la NASA e insegnò ingegneria all’Università di Cincinnati, ma fu chiamato a fare parte delle commissioni che indagarono sugli incidenti dell’Apollo 13 nel 1970 e dello Space Shuttle Challenger nel 1986. Lo si rivide in pubblico in occasione del 30ennale e, più recentemente, del 40ennale della missione Apollo 11, ritrovandosi con i compagni di viaggio Aldrin e Collins, e ricevendo insieme a loro nel 2011 la Medaglia d’oro del Congresso, la più alta onorificenza civile statunitense. Per lui il programma Apollo era servito a dimostrare che l’umanità può aspirare a superare i confini del pianeta Terra. Neil Armstrong è scomparso nel 2012 all’età di 82 anni.
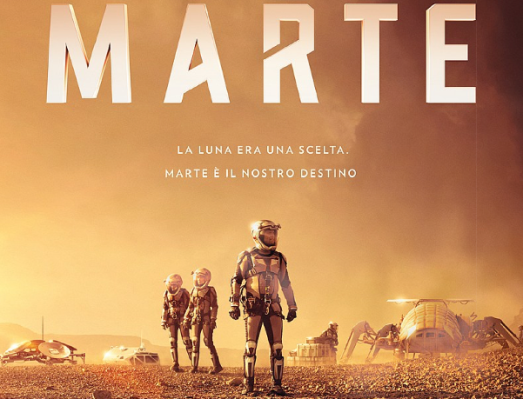
da Sorrentino | Nov 15, 2016 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Recensioni
 Il Pianeta Rosso e il desiderio di mettervi piede entro la prima metà degli anni ’30. Un riassunto del futuro prossimo nelle sei puntate della serie “Mars” in onda su National Geographic Channel a partire dal 15 novembre 2016. Il tutto lascia immaginare cosa dovrebbe avvenire nei successivi 17 anni, culminante con la prima missione con equipaggio che sbarca su Marte. La regia è di Ron Howard (lo stesso che ha firmato Apollo 13), decisamente nutrita la lista dei consulenti che hanno concorso alla stesura quanto più veritiera dell’impresa destinata a venire. Si va dal CEO di SpaceX Elon Musk, il cui annuncio di una missione umana su Marte alla platea del congresso internazionale di astronautica a Guadalajara a fine settembre ha fatto scalpore nella comunità scientifica e spaziale, all’astrofisico Neil deGrasse Tyson, direttore dello Hayden Planetarium, Jennifer Trosper, manager della missione Mars 2020 al JPL, Andy Weir, autore di “The Martian”, Robert Zubrin, presidente di The Mars Society e di Pioneer Astronautics.
Il Pianeta Rosso e il desiderio di mettervi piede entro la prima metà degli anni ’30. Un riassunto del futuro prossimo nelle sei puntate della serie “Mars” in onda su National Geographic Channel a partire dal 15 novembre 2016. Il tutto lascia immaginare cosa dovrebbe avvenire nei successivi 17 anni, culminante con la prima missione con equipaggio che sbarca su Marte. La regia è di Ron Howard (lo stesso che ha firmato Apollo 13), decisamente nutrita la lista dei consulenti che hanno concorso alla stesura quanto più veritiera dell’impresa destinata a venire. Si va dal CEO di SpaceX Elon Musk, il cui annuncio di una missione umana su Marte alla platea del congresso internazionale di astronautica a Guadalajara a fine settembre ha fatto scalpore nella comunità scientifica e spaziale, all’astrofisico Neil deGrasse Tyson, direttore dello Hayden Planetarium, Jennifer Trosper, manager della missione Mars 2020 al JPL, Andy Weir, autore di “The Martian”, Robert Zubrin, presidente di The Mars Society e di Pioneer Astronautics.
Il docufilm “Mars” regala una eccezionale qualità delle immagini, che danno la sensazione di tuffarsi nei panorami rimandati dalle sonde in orbita marziana, Mars Recoinassance Orbiter della NASA e Mars Express dell’ESA, e il rover Curiosity. Tuttavia, come riportano le recensioni, la sensazione di realismo arriva prima di tutto dalla tempistica: il calendario segna la data del 2033. Musk ha prospettato lo sbarco dell’uomo su Marte per il 2024, ma ha precisato che rispetterà questa data “se le cose andranno super bene”, e che nonostante farà del suo meglio, non è sicuro di farcela. Di fatto, la prima missione viene ipotizzata con un posticipo di 9 anni e ciò corrisponde ai tempi indicati dalla NASA.
La temperatura media su Marte è di -75°C e la sua sottile atmosfera è composta per oltre il 90% da anidride carbonica. Nonostante le condizioni proibitive, lo scienziato della NASA Chris McKay è convinto che un giorno l’uomo vivrà su Marte, trasformato nel corso del tempo in un pianeta dai cieli blu, con oceani, fiumi e foreste di conifere. National Geographic Channel in questo documentario mostra cosa significa trasformare un pianeta come Marte in una seconda Terra. Si viaggia in Messico sulla cima di un vulcano, dove insediamenti di alberi d’alta quota possono svelare il segreto di come far crescere alberi su Marte. Attraverso una computer grafica assolutamente realistica si prova ad immaginare come potrà apparire un giorno il Pianeta Rosso ormai divenuto “Verde”.
Inoltre c’è il sito MakeMarsHome.com con il conto alla rovescia per l’atterraggio su Marte, il percorso che sta seguendo l’astronave Daedalus per arrivare a destinazione, il sito di atterraggio su Marte e – fra le altre cose – un documentario “reale” della International Mars Science Foundation con il riepilogo della missione, la spiegazione degli obiettivi e dettagli sull’equipaggio.

da Sorrentino | Ott 21, 2016 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Politica Spaziale, Primo Piano

La città di Trento ospita il 24 ottobre il primo International Space Forum for Global Challenges organizzato dall’International Astronautical Federation (IAF), dall’International Accademy of Astronautics (IAA) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L’ideazione dell’International Space Forum for Global Challenges parte dalla considerazione che le accademie spaziali e le università sono presenti in tutto il mondo, una rete capillare di conoscenze e specializzazioni nelle discipline scientifiche e tecnologiche alla base dei programmi spaziali. Questa rete è una ricchezza fondamentale, sia per i paesi sviluppati che per i paesi in via di sviluppo a cui l’evento è particolarmente dedicato. Per mezzo dell’attività del Forum di Trento verrà rafforzato il coinvolgimento delle accademie spaziali e delle università nell’elaborazione delle politiche spaziali per far fronte a sfide globali tra le quali la tutela dell’ambiente, i cambiamenti climatici e la gestione dei “big Data”. Questi i principali temi del Forum di Trento, primo convegno internazionale a livello ministeriale sulle politiche della formazione e della ricerca associate ai programmi spaziali, e coinvolgerà membri di governo responsabili della formazione e dello spazio, così come rappresentanti delle agenzie spaziali nazionali e di istituzioni accademiche e universitarie di diversi Paesi. Con questo incontro di alto livello che coinvolge ben 83 Paesi, l’Italia conferma il suo ruolo di primo piano nel promuovere il progresso della scienza e della tecnologia con lo sviluppo di partnership internazionali per una crescita sempre più sostenibile delle attività spaziali a beneficio dell’umanità. Al termine del summit, ospitato dalle 10 alle 17 nel Palazzo della Provincia di Trento, l’illustrazione dei i punti della risoluzione approvata dagli organizzatori del vertice, presente il Ministro della Istruzione, Università e Ricerca Stefania Giannini.

 Il valore della Space Economy in Italia può essere bene rappresentato da pochi ma essenziali numeri: un peso occupazionale di 6.000 addetti, un fatturato da 1,6 miliardi di euro, ulteriori fond per 500 milioni nel 2016 di cui 360 stanziati dal Cipe e 140 milioni dalle Regioni, che metteranno in moto un miliardo di euro di investimenti per le industrie con tempi di assegnazione agli inizi dell’autunno 2017. E per comprendere quanto le attività spaziali incidano sulla crescita economica del nostro Paese e fungano da motore della ricerca scientifica, basta ricordare che ogni euro investito ne genera da 3 a 5 in altri settori. Un quadro delineato nel corso di un convegno promosso da Air Press al Centro Studi Americani di Roma, con la partecipazione dei titolari dei dicasteri dello Sviluppo Economico e del Miur insieme ai principali attori nazionali dello Spazio, e servito a fare il punto su strategie e potenzialità dell’Italia che, nel comparto specifico, restano alte ma necessitano di maggiori sinergie. Su questo punto, infatti, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ha rimarcato la necessità di fare sistema per aumentare la competitività del nostro Paese, che pure riveste un ruolo di assoluta eccellenza sia a livello europeo che internazionale. Ma c’è ampio margine di crescita e per allargare il fronte delle collaborazioni. E a tale proposito, sia il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che quello dell’Istruzione e della Ricerca, Valeria Fedeli, hanno confermato l’intenzione di tramutare la cabina di regia dello Spazio promossa nel 2016 in un Comitato interministeriale per lo Spazio.
Il valore della Space Economy in Italia può essere bene rappresentato da pochi ma essenziali numeri: un peso occupazionale di 6.000 addetti, un fatturato da 1,6 miliardi di euro, ulteriori fond per 500 milioni nel 2016 di cui 360 stanziati dal Cipe e 140 milioni dalle Regioni, che metteranno in moto un miliardo di euro di investimenti per le industrie con tempi di assegnazione agli inizi dell’autunno 2017. E per comprendere quanto le attività spaziali incidano sulla crescita economica del nostro Paese e fungano da motore della ricerca scientifica, basta ricordare che ogni euro investito ne genera da 3 a 5 in altri settori. Un quadro delineato nel corso di un convegno promosso da Air Press al Centro Studi Americani di Roma, con la partecipazione dei titolari dei dicasteri dello Sviluppo Economico e del Miur insieme ai principali attori nazionali dello Spazio, e servito a fare il punto su strategie e potenzialità dell’Italia che, nel comparto specifico, restano alte ma necessitano di maggiori sinergie. Su questo punto, infatti, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ha rimarcato la necessità di fare sistema per aumentare la competitività del nostro Paese, che pure riveste un ruolo di assoluta eccellenza sia a livello europeo che internazionale. Ma c’è ampio margine di crescita e per allargare il fronte delle collaborazioni. E a tale proposito, sia il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che quello dell’Istruzione e della Ricerca, Valeria Fedeli, hanno confermato l’intenzione di tramutare la cabina di regia dello Spazio promossa nel 2016 in un Comitato interministeriale per lo Spazio. Lapidario Luigi Pasquali, ad di Telespazio e direttore del settore Spazio di Leonardo Finmeccanica, nell’osservare come per anni sia stata data una spinta importante allo sviluppo di tecnologie innovative per lo spazio, ma ora sia arrivato il momento di fornire la spinta a usarle. “Ora diventiamo consumatori, cioè produciamo sviluppo e noi come Telespazio sviluppiamo servizi dallo spazio”. Pasquali rimarca anche il ruolo dell`Italia, che si inserisce in una più ampia cornice europea come testimoniano i numerosi programmi congiunti. “L’avvio di una strategia spaziale comune, come testimoniato da programmi come Galileo, Copernicus ed Egnos, segna un passaggio epocale e la disponibilità del governo ad iniettare risorse è un aspetto fondamentale per lo sviluppo della space economy. C’è bisogno di una pianificazione nazionale che si affianchi alle strategie dei soggetti privati”.
Lapidario Luigi Pasquali, ad di Telespazio e direttore del settore Spazio di Leonardo Finmeccanica, nell’osservare come per anni sia stata data una spinta importante allo sviluppo di tecnologie innovative per lo spazio, ma ora sia arrivato il momento di fornire la spinta a usarle. “Ora diventiamo consumatori, cioè produciamo sviluppo e noi come Telespazio sviluppiamo servizi dallo spazio”. Pasquali rimarca anche il ruolo dell`Italia, che si inserisce in una più ampia cornice europea come testimoniano i numerosi programmi congiunti. “L’avvio di una strategia spaziale comune, come testimoniato da programmi come Galileo, Copernicus ed Egnos, segna un passaggio epocale e la disponibilità del governo ad iniettare risorse è un aspetto fondamentale per lo sviluppo della space economy. C’è bisogno di una pianificazione nazionale che si affianchi alle strategie dei soggetti privati”.
 I Paesi dell’Unione Europea si sono ritrovati a Bruxelles per discutere la strada da seguire in tema di programmi e strategie spaziali e delle relative opportunità il settore offre per lo sviluppo delle attività tecnologiche avanzate a ogni singolo Paese. L’occasione è stata la nona Conferenza sulla European Space Policy, che ha ripreso i contenuti della Comunicazione prodotta dalla Commissione Europea sulla Strategia Spaziale per l’Europa, pubblicata lo scorso 26 ottobre. Un confronto che ha coinvolto i rappresentanti di Parlamento e Commissione Europei, dell’Agenzia Spaziale Europea e delle Agenzie Spaziali nazionali.
I Paesi dell’Unione Europea si sono ritrovati a Bruxelles per discutere la strada da seguire in tema di programmi e strategie spaziali e delle relative opportunità il settore offre per lo sviluppo delle attività tecnologiche avanzate a ogni singolo Paese. L’occasione è stata la nona Conferenza sulla European Space Policy, che ha ripreso i contenuti della Comunicazione prodotta dalla Commissione Europea sulla Strategia Spaziale per l’Europa, pubblicata lo scorso 26 ottobre. Un confronto che ha coinvolto i rappresentanti di Parlamento e Commissione Europei, dell’Agenzia Spaziale Europea e delle Agenzie Spaziali nazionali. 
 La tradizionale conferenza stampa di inizio anno del direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, indetta per presentare i programmi e i principali appuntamenti del 2017, ha rivelato un problema, per il momento senza conseguenze operative, agli orologi dei 18 satelliti attualmente in orbita del sistema di navigazione Galileo. Jan Woerner ha spiegato che, dopo l’avvio dell’avvio della fase operativa sperimentale del Gps europeo avvenuto il 15 dicembre 2016 con 18 dei 30 satelliti destinati a formare la costellazione completa, nove dei 72 orologi di altissima precisione attualmente a bordo delle singole piattaforme hanno manifestato malfunzionamento. Ogni satellite ha una dotazione di quattro orologi, due al rubidio e due maser all’idrogeno. Si è riscontrato che quelli che non rispondono ai requisiti nominali sono sei maser a idrogeno passivo e tre orologi atomici al rubidio. Fortunatamente, perché un satellite svolga appieno la sua missione è sufficiente che almeno due dei quattro orologi atomici funzioni. Il che vuol dire che il programma Galileo è salvo, ma occorre risalire rapidamente alla causa del problema e individuare le soluzioni idonee a verificare che i prossimi 48 orologi a bordo della dozzina di satelliti mancanti funzionino regolarmente. Ciò per scongiurare ulteriore ritardi nel programma dei lanci, il prossimo dei quali è in calendario il 9 agosto dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese quando è previsto che un razzo Ariane 5 trasferisca in orbita quattro satelliti Galileo.
La tradizionale conferenza stampa di inizio anno del direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea, indetta per presentare i programmi e i principali appuntamenti del 2017, ha rivelato un problema, per il momento senza conseguenze operative, agli orologi dei 18 satelliti attualmente in orbita del sistema di navigazione Galileo. Jan Woerner ha spiegato che, dopo l’avvio dell’avvio della fase operativa sperimentale del Gps europeo avvenuto il 15 dicembre 2016 con 18 dei 30 satelliti destinati a formare la costellazione completa, nove dei 72 orologi di altissima precisione attualmente a bordo delle singole piattaforme hanno manifestato malfunzionamento. Ogni satellite ha una dotazione di quattro orologi, due al rubidio e due maser all’idrogeno. Si è riscontrato che quelli che non rispondono ai requisiti nominali sono sei maser a idrogeno passivo e tre orologi atomici al rubidio. Fortunatamente, perché un satellite svolga appieno la sua missione è sufficiente che almeno due dei quattro orologi atomici funzioni. Il che vuol dire che il programma Galileo è salvo, ma occorre risalire rapidamente alla causa del problema e individuare le soluzioni idonee a verificare che i prossimi 48 orologi a bordo della dozzina di satelliti mancanti funzionino regolarmente. Ciò per scongiurare ulteriore ritardi nel programma dei lanci, il prossimo dei quali è in calendario il 9 agosto dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese quando è previsto che un razzo Ariane 5 trasferisca in orbita quattro satelliti Galileo.

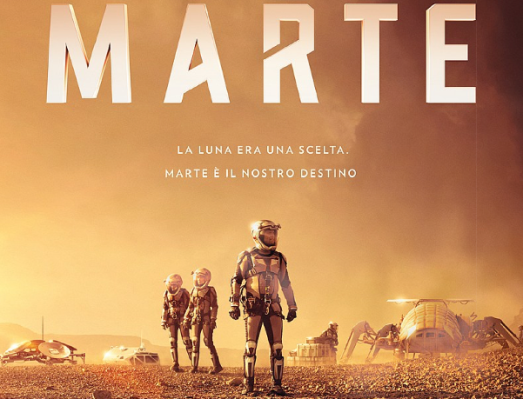
 Il Pianeta Rosso e il desiderio di mettervi piede entro la prima metà degli anni ’30. Un riassunto del futuro prossimo nelle sei puntate della serie “Mars” in onda su National Geographic Channel a partire dal 15 novembre 2016. Il tutto lascia immaginare cosa dovrebbe avvenire nei successivi 17 anni, culminante con la prima missione con equipaggio che sbarca su Marte. La regia è di Ron Howard (lo stesso che ha firmato Apollo 13), decisamente nutrita la lista dei consulenti che hanno concorso alla stesura quanto più veritiera dell’impresa destinata a venire. Si va dal CEO di SpaceX Elon Musk, il cui annuncio di una missione umana su Marte alla platea del congresso internazionale di astronautica a Guadalajara a fine settembre ha fatto scalpore nella comunità scientifica e spaziale, all’astrofisico Neil deGrasse Tyson, direttore dello Hayden Planetarium, Jennifer Trosper, manager della missione Mars 2020 al JPL, Andy Weir, autore di “The Martian”, Robert Zubrin, presidente di The Mars Society e di Pioneer Astronautics.
Il Pianeta Rosso e il desiderio di mettervi piede entro la prima metà degli anni ’30. Un riassunto del futuro prossimo nelle sei puntate della serie “Mars” in onda su National Geographic Channel a partire dal 15 novembre 2016. Il tutto lascia immaginare cosa dovrebbe avvenire nei successivi 17 anni, culminante con la prima missione con equipaggio che sbarca su Marte. La regia è di Ron Howard (lo stesso che ha firmato Apollo 13), decisamente nutrita la lista dei consulenti che hanno concorso alla stesura quanto più veritiera dell’impresa destinata a venire. Si va dal CEO di SpaceX Elon Musk, il cui annuncio di una missione umana su Marte alla platea del congresso internazionale di astronautica a Guadalajara a fine settembre ha fatto scalpore nella comunità scientifica e spaziale, all’astrofisico Neil deGrasse Tyson, direttore dello Hayden Planetarium, Jennifer Trosper, manager della missione Mars 2020 al JPL, Andy Weir, autore di “The Martian”, Robert Zubrin, presidente di The Mars Society e di Pioneer Astronautics.










