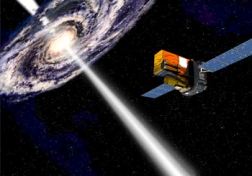La scoperta di un buco nero al centro della nostra galassia è solo una delle tante risposte relative ai segreti dell’Universo, ottenute grazie all’impiego di strumenti avanzati che operano al di fuori della cortina dell’atmosfera e dell’influenza del campo magnetico terrestre. Il satellite Integral, lanciato il 17 ottobre 2002 dall’Agenzia Spaziale Europea con il razzo vettore russo Proton dalla base di Baikonour, ha permesso per l’appunto di osservare il cuore della Via Lattea e confermare la presenza del buco nero. Un risultato ottenuto grazie alla grande risoluzione spettrale consentita dalle apparecchiature di bordo, dotate di una sensibilità mai raggiunta in precedenza. Il telescopio per raggi gamma Ibis, che rappres
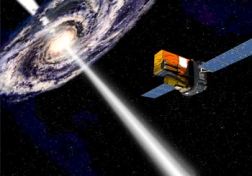 enta la componente principale del contenuto italiano alla missione Integral, consente di puntare con estrema precisione le regioni cosmiche dove sono presenti queste sorgenti e rivelare i singoli oggetti celesti che le emettono, contribuendo ad acquisire informazioni fondamentali su natura e caratteristiche di questi fenomeni, a cominciare dalla luminescenza.
enta la componente principale del contenuto italiano alla missione Integral, consente di puntare con estrema precisione le regioni cosmiche dove sono presenti queste sorgenti e rivelare i singoli oggetti celesti che le emettono, contribuendo ad acquisire informazioni fondamentali su natura e caratteristiche di questi fenomeni, a cominciare dalla luminescenza.
Pietro Ubertini, direttore dell’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica, intervenuto allo Space Day di BergamoScienza, ritiene indispensabile concepire nuovi e ancora più potenti strumenti di osservazione pronti a succedere a Integral, che nel frattempo continua la missione nella sua orbita eccentrica di 72 ore a 155mila km dalla Terra.
Parlare di buchi neri e lampi gamma significa fare un viaggio virtuale attraverso l’universo violento. L’identikit del buco nero presente al centro della nostra galassia è tranquillizzante dal punto di vista astrofisico. Ha una massa 3,7 volte quella del Sole e intorno a sé ha creato un vuoto cosmico. Soprattutto, corrisponde al punto matematico intorno al cui ruota la nostra galassia. Nelle altre galassie ne sono stati scoperti una dozzina, ma si pensa che ce ne siano milioni.
“Integral ha passato i primi cinque anni a osservare il centro della galassia – spiega Ubertini, principal investigator della missione – Poi si è deciso di guardare all’esterno della nostra galassia per capire come i buchi neri abbiano influito sulla formazione dell’universo. Non sono solo mostri gravitazionali, ma aiutano a capire come l’universo di idrogeno si è trasformato ed evoluto in stelle e galassie. Integral ha scoperto 700 galassie che emettono grosse quantità di raggi gamma. Se capiamo la correlazione tra collasso dell’idrogeno e momenti successivi alla formazione di un buco nero, possiamo ritenere di aver interpretato il funzionamento dell’universo”.
Finora sono stati osservati cinquemila lampi gamma ma nessuno di questi proveniente da un buco nero con massa 100 o 1000 volte più grande di quella del Sole. Nel contempo si è appurato come molti dei sistemi binari abbiano visto una delle due stelle trasformarsi in buco nero (ne sono state scoperte oltre 500). Fenomeni che si intrecciano con il grande interrogativo dell’energia e della materia oscura che compongono il 97% dell’universo, a sua volta formato da stringhe ovvero strisce di instabilità gravitazionale. Proprio nel giugno 2012 l’Agenzia Spaziale Europea ha approvato la missione Euclid, nuovo telescopio spaziale che verrà lanciato nel 2020 con un vettore Soyuz dalla Guyana Francese e, operando nel punto di equilibrio di Lagrange L2 (uno dei punti di bilanciamento delle azioni gravitazionali di Sole e Terra) avrà il compito di realizzare il censimento delle galassie fino a 10 miliardi di anni di età e rivelare le forze che accelerano l’espansione dell’universo, ovvero quella energia oscura che rappresenta oltre due terzi della massa e dell’energia dell’universo.