
da Sorrentino | Giu 25, 2019 | Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari
 Ennesimo esame superato per SpaceX che ha effettuato un lancio notturno con il potente razzo Falcon Heay, alla sua terza missione denominata “Space Test Program-2 (STP-2), lo stesso che nel 2018 accompagnò il viaggio di una Tesla Roadstar verso Marte. A bordo 24 satellite da posizione in tre orbite diverse durante le sei ore successive alla partenza da Cape Canaveral, avvenuta quando in Italia erano le 8.28 del mattino. L’operazione di rilascio in tempi e a quote orbitali differenti del carico utile è stata prevista mediante quattro accensioni del secondo stadio del Falcon Heavy. Come da programma, SpaceX ha recuperato e fatto riatterrare sulla piattaforma del centro spaziale in Florida i due booster del razzo vettore, che hanno toccato terra in verticale rispettivamente 8’45” e 11’15” dopo il lancio. Il carico utile per complessivi 3,7 tonnellate comprende una serie di strumentazioni ed esperimenti scientifici della NASA, del NOAA, dell’Aeronautica militare statunitense, e quelli messi a punto da università e piccole compagnie spaziali private. Tra gli utenti privati figura anche Celestis, azienda specializzata nel lancio di ceneri umane nello Spazio, che ha trasferito in orbita, all’interno della capsula Orbital Test Bed (in cui peraltro la NASA ha posizionato l’orologio atomico miniaturizzato Deep Space Atomic Clock,, le urne con le cremazioni di 152 persone, comprese quelle dell’astronauta americano Bill Pogue, protagonista di una missione di 84 giorni a bordo dello Skylab negli anni ’70. Heritage Flight, questo il nome del carico dell’ultimo viaggio, resterà in orbita 25 anni prima di ricadere e bruciare dissolvendosi nell’atmosfera terreste. La parte scientifica più interessante è legata alla Planetary Society, che ha lanciato LightSail 2, un piccolo satellite che una volta in orbita dispiegherà una vela solare. Un programma sostenuto da crowfunding che permetterà di testare i vantaggi della spinta prodotti dai fotoni per viaggiare nel sistema solare senza ausilio di motori e pannelli solari.
Ennesimo esame superato per SpaceX che ha effettuato un lancio notturno con il potente razzo Falcon Heay, alla sua terza missione denominata “Space Test Program-2 (STP-2), lo stesso che nel 2018 accompagnò il viaggio di una Tesla Roadstar verso Marte. A bordo 24 satellite da posizione in tre orbite diverse durante le sei ore successive alla partenza da Cape Canaveral, avvenuta quando in Italia erano le 8.28 del mattino. L’operazione di rilascio in tempi e a quote orbitali differenti del carico utile è stata prevista mediante quattro accensioni del secondo stadio del Falcon Heavy. Come da programma, SpaceX ha recuperato e fatto riatterrare sulla piattaforma del centro spaziale in Florida i due booster del razzo vettore, che hanno toccato terra in verticale rispettivamente 8’45” e 11’15” dopo il lancio. Il carico utile per complessivi 3,7 tonnellate comprende una serie di strumentazioni ed esperimenti scientifici della NASA, del NOAA, dell’Aeronautica militare statunitense, e quelli messi a punto da università e piccole compagnie spaziali private. Tra gli utenti privati figura anche Celestis, azienda specializzata nel lancio di ceneri umane nello Spazio, che ha trasferito in orbita, all’interno della capsula Orbital Test Bed (in cui peraltro la NASA ha posizionato l’orologio atomico miniaturizzato Deep Space Atomic Clock,, le urne con le cremazioni di 152 persone, comprese quelle dell’astronauta americano Bill Pogue, protagonista di una missione di 84 giorni a bordo dello Skylab negli anni ’70. Heritage Flight, questo il nome del carico dell’ultimo viaggio, resterà in orbita 25 anni prima di ricadere e bruciare dissolvendosi nell’atmosfera terreste. La parte scientifica più interessante è legata alla Planetary Society, che ha lanciato LightSail 2, un piccolo satellite che una volta in orbita dispiegherà una vela solare. Un programma sostenuto da crowfunding che permetterà di testare i vantaggi della spinta prodotti dai fotoni per viaggiare nel sistema solare senza ausilio di motori e pannelli solari.

da Sorrentino | Giu 22, 2019 | Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Stazione Spaziale

Paolo Nespoli training
Si è definito “ingegnere al cubo” Paolo Nespoli, che ieri ha ricevuto dal Politecnico di Torino una prestigiosa laurea honoris causa, potendo annoverare insieme alle tre missioni in orbita altrettanti titoli accademici in ingegneria: la laurea in ingegneria aerospaziale conseguita a New York, in ingegneria meccanica all’Università di Firenze, e quello del Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale a Torino, dove ha tenuto la“lectio magistralis” al cospetto di centinaia di studenti nell’Aula Magna Agnelli.
Mezz’ora per ripercorrere l’intensa carriera di astronauta, con la prima missione nel 2007 a bordo dello Shuttle Endeavour, con cui raggiunse la stazione spaziale supervisionando la manovra di attracco di uno dei “Nodi” alla stazione, realizzati proprio a Torino da Thales Alenia Space. Nel dicembre 2010 la seconda esperienza con la missione di lunga durata a bordo della Soyuz e sei mesi trascorsi in orbita partendo con una Soyuz, per poi culminare da sessantenne nel 2017 con la seconda missione di lunga durata. In totale, Paolo Nespoli ha accumulato quasi 10 mesi di permanenza nello spazio. L’invito rivolto agli studenti, tra i quali si è augurato potesse esserci colui o colei che metterà piede su Marte, è stato di «non smettere di sognare» ed essere «predisposti a superare sempre nuovi esami e nuove sfide».

da Sorrentino | Giu 21, 2019 | Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari

Il satellite per le telecomunicazioni T-16 realizzato da Airbus è stato lanciato con successo da Kourou, nella Guyana francese, tramite il lanciatore Ariane 5. T-16 è basato sulla piattaforma geostazionaria Eurostar E3000 di Airbus, estremamente affidabile, ed è il 50° satellite di questo tipo a essere lanciato. Fornirà una capacità satellitare ad alta potenza per i servizi di trasmissione televisiva ad alta disponibilità, incluso il superamento dell’effetto “rain fade”.
Una volta separato dal lanciatore, il satellite Eurostar E3000 utilizzerà il proprio sistema di propulsione chimica per raggiungere l’orbita geostazionaria, cosa che richiederà circa una settimana. Il T-16 fornirà servizi di trasmissione ad alta potenza in bande Ku, Ka e Reverse. Grazie alla sua flessibilità, il satellite può essere utilizzato su cinque diversi slot orbitali (da 99° Ovest a 119° Ovest) e coprirà gli Stati Uniti continentali, l’Alaska, le Hawaii e Porto Rico. Con una massa al lancio di 6.330 kg e una potenza di 18 kW, il satellite è progettato per svolgere un servizio in orbita della durata di 15 anni
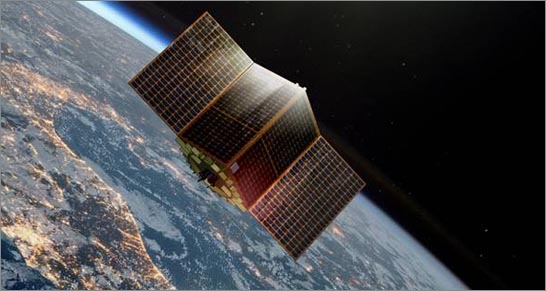
da Sorrentino | Giu 19, 2019 | Industria, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari
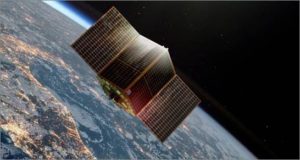 Informazioni satellitari sempre più precise e nuovi servizi di osservazione della Terra saranno presto disponibili, grazie a mini veicoli aerospaziali in materiale innovativo (meno di 500 chili di peso), dotati di sistemi propulsivi all’avanguardia che consentono di operare in orbite basse. È l’obiettivo del progetto “Close to the Earth” co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con oltre 9 milioni di euro che coinvolge ENEA nell’ambito del Distretto Tecnologico Aerospaziale di Brindisi (DTA).
Informazioni satellitari sempre più precise e nuovi servizi di osservazione della Terra saranno presto disponibili, grazie a mini veicoli aerospaziali in materiale innovativo (meno di 500 chili di peso), dotati di sistemi propulsivi all’avanguardia che consentono di operare in orbite basse. È l’obiettivo del progetto “Close to the Earth” co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con oltre 9 milioni di euro che coinvolge ENEA nell’ambito del Distretto Tecnologico Aerospaziale di Brindisi (DTA).
“In orbite basse l’attrito atmosferico impone un utilizzo maggiore dei propulsori e ciò comporta un consumo più elevato di propellente, ma grazie alla nuova tecnologia di propulsione elettrica air-breathing, che sfrutta i gas presenti nell’atmosfera, sarà possibile far orbitare i satelliti entro i 250 km dalla Terra, senza bisogno di propellente a bordo”, spiega la ricercatrice ENEA Antonella Rizzo, responsabile scientifico del progetto. Nell’ambito del progetto spetteranno all’ENEA la realizzazione di rivestimenti, anche multistrato, tramite un processo innovativo di deposizione mediante evaporazione (Physical Vapour Deposition), in grado di proteggere i componenti plastici o metallici dei veicoli dalla degradazione al contatto con l’ossigeno atomico. Questi materiali innovativi verranno testati in uno speciale laboratorio dove sarà ricostruito l’ambiente atmosferico delle orbite spaziali molto vicine alla Terra: un vero e proprio simulatore in grado di riprodurre le condizioni dello spazio in termini di pressione (fino a 10-7 mbar) e temperatura (dai 180 °C del lato terrestre irraggiato dal Sole ai – 180 °C di quello in ombra). I ricercatori del Centro Ricerche ENEA di Brindisi saranno impegnati inoltre nello studio di trattamenti superficiali innovativi in grado di modificare le proprietà termo-ottiche di alcune parti del satellite che consentiranno di convertire il calore di scarto in energia elettrica.“L’esperienza pluriennale nel campo dei rivestimenti funzionali e protettivi dei laboratori del Centro ENEA di Brindisi e l’integrazione delle conoscenze e competenze scientifiche, accademiche ed industriali sperimentata con successo in altri progetti di ricerca, permetterà di consolidare il ruolo dell’ENEA come socio del DTA all’interno del comparto aerospaziale pugliese”, aggiunge Antonella Rizzo. “Riteniamo inoltre che i nuovi strumenti di osservazione della Terra a quote così basse e con lunghe vite operative daranno un grosso impulso ai servizi satellitari quali ad esempio il monitoraggio ambientale, aprendo la strada a nuovi settori applicativi”, conclude Rizzo. Oltre all’ENEA e aziende del settore come GAP e IMT, partecipano al progetto in ambito DTA le Università di Bari e del Salento, CNR, Sitael, Planetek, Enginsoft e Blackshape.

da Sorrentino | Giu 18, 2019 | Ambiente, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari
 Al Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget l’Agenzia Spaziale Italiana ha mostrato le prime immagini provenienti dal satellite PRISMA, esempio assoluto di eccellenza scientifica e industriale italiana, lanciato il 22 marzo 2019 con il vettore VEGA prodotto da AVIO, e realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica iperspettrale, oltre a diversi equipaggiamenti di bordo, come i sensori d’assetto e il pannello solare. Grazie al centro di controllo della missione situata al centro del Fucino e all’attività di acquisizione e elaborazione dei dati da parte del Centro Spaziale di Matera dell’ASI, sono state prodotte spettacolari fotografie catturate in Italia, Perù e Iraq dal potente sensore iperspettrale a bordo di PRISMA durante il Commissioning del sistema. Il satellite PRISMA, fin dalla fase di collaudo in orbita, dimostra così di rappresentare un guardiano in grado di far luce sullo stato di salute del nostro Pianeta e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le immagini, ricevute dal Centro Spaziale di Matera, dove opera un team composto da personale specializzato di ASI, Leonardo, Planetek, Telespazio/e-GEOS e OHB Italia, sono state processate con il supporto di scienziati di IREA/CNR e Università degli studi di Milano, Bicocca.
Al Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget l’Agenzia Spaziale Italiana ha mostrato le prime immagini provenienti dal satellite PRISMA, esempio assoluto di eccellenza scientifica e industriale italiana, lanciato il 22 marzo 2019 con il vettore VEGA prodotto da AVIO, e realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica iperspettrale, oltre a diversi equipaggiamenti di bordo, come i sensori d’assetto e il pannello solare. Grazie al centro di controllo della missione situata al centro del Fucino e all’attività di acquisizione e elaborazione dei dati da parte del Centro Spaziale di Matera dell’ASI, sono state prodotte spettacolari fotografie catturate in Italia, Perù e Iraq dal potente sensore iperspettrale a bordo di PRISMA durante il Commissioning del sistema. Il satellite PRISMA, fin dalla fase di collaudo in orbita, dimostra così di rappresentare un guardiano in grado di far luce sullo stato di salute del nostro Pianeta e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le immagini, ricevute dal Centro Spaziale di Matera, dove opera un team composto da personale specializzato di ASI, Leonardo, Planetek, Telespazio/e-GEOS e OHB Italia, sono state processate con il supporto di scienziati di IREA/CNR e Università degli studi di Milano, Bicocca.
PRISMA, di proprietà dell’ASI e realizzato da una RTI guidata da OHB Italia e Leonardo, è il primo sistema di osservazione della Terra europeo dotato di un sensore ottico iperspettrale innovativo, in grado di effettuare dallo Spazio un’analisi chimico-fisica delle aree sotto osservazione. La prima immagine ritrae il Trasimeno, quarto lago italiano per estensione, un bacino naturale di 128 km2, di cui PRIMA, in meno di 2 secondi, ha misurato la torbidità, rilevando le acque più limpide e le colonie di alghe. In Perù, PRISMA ha rilevato il contenuto di acqua nelle colture, distinguendo i campi ben irrigati da quelli affetti da siccità.
Il monitoraggio dell’acqua da parte di PRISMA, applicato alle foreste, può fornire un segnale precursore del rischio incendio, come dimostra la terza immagine che riprende l’area naturalistica Castel Fusano (Roma). Un contributo fondamentale, giacché l’85% dei 65mila incendi registrati annualmente in Europa si verificano nell’area del Mediterraneo.
Anche gli incendi di gas connessi all’estrazione petrolifera a Bassora (Iraq) sono stati ripresi da PRISMA. Oltre alla capacità di determinare con precisione l’estensione dell’incendio, la tecnologia iperspettrale permette di riconoscere le sostanze chimiche generate dalla combustione: anidride carbonica (CO2) e altri idrocarburi hanno la loro impronta digitale iperspettrale e PRISMA riesce a misurarla caratterizzando l’inquinamento atmosferico.
PRISMA rivela tutte le sue capacità di monitoraggio del delicato ecosistema terrestre, fornendo un contributo rilevante al controllo dell’inquinamento e dei cambiamenti ambientali, un supporto fondamentale per la gestione delle risorse naturali e delle emergenze.

 Ennesimo esame superato per SpaceX che ha effettuato un lancio notturno con il potente razzo Falcon Heay, alla sua terza missione denominata “Space Test Program-2 (STP-2), lo stesso che nel 2018 accompagnò il viaggio di una Tesla Roadstar verso Marte. A bordo 24 satellite da posizione in tre orbite diverse durante le sei ore successive alla partenza da Cape Canaveral, avvenuta quando in Italia erano le 8.28 del mattino. L’operazione di rilascio in tempi e a quote orbitali differenti del carico utile è stata prevista mediante quattro accensioni del secondo stadio del Falcon Heavy. Come da programma, SpaceX ha recuperato e fatto riatterrare sulla piattaforma del centro spaziale in Florida i due booster del razzo vettore, che hanno toccato terra in verticale rispettivamente 8’45” e 11’15” dopo il lancio. Il carico utile per complessivi 3,7 tonnellate comprende una serie di strumentazioni ed esperimenti scientifici della NASA, del NOAA, dell’Aeronautica militare statunitense, e quelli messi a punto da università e piccole compagnie spaziali private. Tra gli utenti privati figura anche Celestis, azienda specializzata nel lancio di ceneri umane nello Spazio, che ha trasferito in orbita, all’interno della capsula Orbital Test Bed (in cui peraltro la NASA ha posizionato l’orologio atomico miniaturizzato Deep Space Atomic Clock,, le urne con le cremazioni di 152 persone, comprese quelle dell’astronauta americano Bill Pogue, protagonista di una missione di 84 giorni a bordo dello Skylab negli anni ’70. Heritage Flight, questo il nome del carico dell’ultimo viaggio, resterà in orbita 25 anni prima di ricadere e bruciare dissolvendosi nell’atmosfera terreste. La parte scientifica più interessante è legata alla Planetary Society, che ha lanciato LightSail 2, un piccolo satellite che una volta in orbita dispiegherà una vela solare. Un programma sostenuto da crowfunding che permetterà di testare i vantaggi della spinta prodotti dai fotoni per viaggiare nel sistema solare senza ausilio di motori e pannelli solari.
Ennesimo esame superato per SpaceX che ha effettuato un lancio notturno con il potente razzo Falcon Heay, alla sua terza missione denominata “Space Test Program-2 (STP-2), lo stesso che nel 2018 accompagnò il viaggio di una Tesla Roadstar verso Marte. A bordo 24 satellite da posizione in tre orbite diverse durante le sei ore successive alla partenza da Cape Canaveral, avvenuta quando in Italia erano le 8.28 del mattino. L’operazione di rilascio in tempi e a quote orbitali differenti del carico utile è stata prevista mediante quattro accensioni del secondo stadio del Falcon Heavy. Come da programma, SpaceX ha recuperato e fatto riatterrare sulla piattaforma del centro spaziale in Florida i due booster del razzo vettore, che hanno toccato terra in verticale rispettivamente 8’45” e 11’15” dopo il lancio. Il carico utile per complessivi 3,7 tonnellate comprende una serie di strumentazioni ed esperimenti scientifici della NASA, del NOAA, dell’Aeronautica militare statunitense, e quelli messi a punto da università e piccole compagnie spaziali private. Tra gli utenti privati figura anche Celestis, azienda specializzata nel lancio di ceneri umane nello Spazio, che ha trasferito in orbita, all’interno della capsula Orbital Test Bed (in cui peraltro la NASA ha posizionato l’orologio atomico miniaturizzato Deep Space Atomic Clock,, le urne con le cremazioni di 152 persone, comprese quelle dell’astronauta americano Bill Pogue, protagonista di una missione di 84 giorni a bordo dello Skylab negli anni ’70. Heritage Flight, questo il nome del carico dell’ultimo viaggio, resterà in orbita 25 anni prima di ricadere e bruciare dissolvendosi nell’atmosfera terreste. La parte scientifica più interessante è legata alla Planetary Society, che ha lanciato LightSail 2, un piccolo satellite che una volta in orbita dispiegherà una vela solare. Un programma sostenuto da crowfunding che permetterà di testare i vantaggi della spinta prodotti dai fotoni per viaggiare nel sistema solare senza ausilio di motori e pannelli solari.



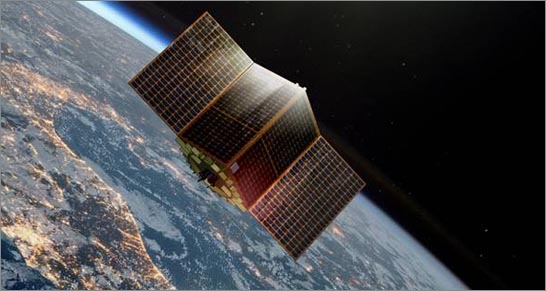
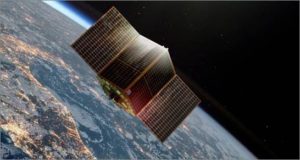 Informazioni satellitari sempre più precise e nuovi servizi di osservazione della Terra saranno presto disponibili, grazie a mini veicoli aerospaziali in materiale innovativo (meno di 500 chili di peso), dotati di sistemi propulsivi all’avanguardia che consentono di operare in orbite basse. È l’obiettivo del progetto “Close to the Earth” co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con oltre 9 milioni di euro che coinvolge ENEA nell’ambito del Distretto Tecnologico Aerospaziale di Brindisi (DTA).
Informazioni satellitari sempre più precise e nuovi servizi di osservazione della Terra saranno presto disponibili, grazie a mini veicoli aerospaziali in materiale innovativo (meno di 500 chili di peso), dotati di sistemi propulsivi all’avanguardia che consentono di operare in orbite basse. È l’obiettivo del progetto “Close to the Earth” co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con oltre 9 milioni di euro che coinvolge ENEA nell’ambito del Distretto Tecnologico Aerospaziale di Brindisi (DTA).
 Al Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget l’Agenzia Spaziale Italiana ha mostrato le prime immagini provenienti dal satellite PRISMA, esempio assoluto di eccellenza scientifica e industriale italiana, lanciato il 22 marzo 2019 con il vettore VEGA prodotto da AVIO, e realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica iperspettrale, oltre a diversi equipaggiamenti di bordo, come i sensori d’assetto e il pannello solare. Grazie al centro di controllo della missione situata al centro del Fucino e all’attività di acquisizione e elaborazione dei dati da parte del Centro Spaziale di Matera dell’ASI, sono state prodotte spettacolari fotografie catturate in Italia, Perù e Iraq dal potente sensore iperspettrale a bordo di PRISMA durante il Commissioning del sistema. Il satellite PRISMA, fin dalla fase di collaudo in orbita, dimostra così di rappresentare un guardiano in grado di far luce sullo stato di salute del nostro Pianeta e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le immagini, ricevute dal Centro Spaziale di Matera, dove opera un team composto da personale specializzato di ASI, Leonardo, Planetek, Telespazio/e-GEOS e OHB Italia, sono state processate con il supporto di scienziati di IREA/CNR e Università degli studi di Milano, Bicocca.
Al Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget l’Agenzia Spaziale Italiana ha mostrato le prime immagini provenienti dal satellite PRISMA, esempio assoluto di eccellenza scientifica e industriale italiana, lanciato il 22 marzo 2019 con il vettore VEGA prodotto da AVIO, e realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica iperspettrale, oltre a diversi equipaggiamenti di bordo, come i sensori d’assetto e il pannello solare. Grazie al centro di controllo della missione situata al centro del Fucino e all’attività di acquisizione e elaborazione dei dati da parte del Centro Spaziale di Matera dell’ASI, sono state prodotte spettacolari fotografie catturate in Italia, Perù e Iraq dal potente sensore iperspettrale a bordo di PRISMA durante il Commissioning del sistema. Il satellite PRISMA, fin dalla fase di collaudo in orbita, dimostra così di rappresentare un guardiano in grado di far luce sullo stato di salute del nostro Pianeta e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le immagini, ricevute dal Centro Spaziale di Matera, dove opera un team composto da personale specializzato di ASI, Leonardo, Planetek, Telespazio/e-GEOS e OHB Italia, sono state processate con il supporto di scienziati di IREA/CNR e Università degli studi di Milano, Bicocca.








