
Hawking, vita straordinaria
 La scienza dell’universo perde il suo prim’attore: l’astrofisico Stephen Hawking si è spento all’età di 76 anni. Lui, capace di superare la terribile esperienza della Sla, la malattia degenerativa che non gli ha impedito di studiare e affermarsi come uno dei più grandi scienziati della storia. Scompare l’uomo della “Teoria del tutto”, che ha inanellato una serie di studi fondamentali per la conoscenza del cosmo, capace di addentrarsi nella fisica dei buchi neri, individuare un particolare tipo di radiazione che prende il suo nome, elaborare un nuovo concetto di evoluzione dell’universo, disseminare con chiarezza e in chiave divulgativa i suoi elaborati scientifici. Non ha sconfitto la Sla, ma è riuscito ad aggirarla, vincendo l’immobilità fino a provare l’esperienza del volo parabolico e vivere, anche se per manciate di secondi, l’assenza di gravità, fino a sentirsi un superman. Lo attendeva anche volo suborbitale con la Virgin Galactic.
La scienza dell’universo perde il suo prim’attore: l’astrofisico Stephen Hawking si è spento all’età di 76 anni. Lui, capace di superare la terribile esperienza della Sla, la malattia degenerativa che non gli ha impedito di studiare e affermarsi come uno dei più grandi scienziati della storia. Scompare l’uomo della “Teoria del tutto”, che ha inanellato una serie di studi fondamentali per la conoscenza del cosmo, capace di addentrarsi nella fisica dei buchi neri, individuare un particolare tipo di radiazione che prende il suo nome, elaborare un nuovo concetto di evoluzione dell’universo, disseminare con chiarezza e in chiave divulgativa i suoi elaborati scientifici. Non ha sconfitto la Sla, ma è riuscito ad aggirarla, vincendo l’immobilità fino a provare l’esperienza del volo parabolico e vivere, anche se per manciate di secondi, l’assenza di gravità, fino a sentirsi un superman. Lo attendeva anche volo suborbitale con la Virgin Galactic.
Per i più Hawking era da considerarsi un predestinato: è venuto alla luce lo stesso giorno in cui, 300 anni prima, si è spento Galileo Galilei, ed è morto nel giorno della nascita di Albert Einstein, 130 anni dopo. Dal 1976 al 2009 si è seduto dietro la cattedra che fu di Isaac Newton, a Cambridge. Hawking ha accesso letteralmente acceso la luce sui punti oscuri dell’Universo, elaborando la tesi basata sull’integrazione della meccanica quantistica con la teoria della relatività di Einstein, confluita nella famosa “Teoria del tutto”, che ha dato vita al film biografico firmato dal regista James Marsh nel 2014. L’ultima, importanza formulazione sull’esistenza dell’universo è stata sviluppata insieme al fisico Thomas Hertog, del Cern di Ginevra, secondo cui non ci sarebbe stato un solo inizio, ma il cosmo che conosciamo sarebbe ciò che è rimasto dopo una serie di eventi rapidi e concatenati dopo il Big Bang. Di una cosa si può essere certi. La scomparsa di Stephen Hawking non chiude un capitolo, ma lascia aperte molte finestre da cui affacciarsi per svelare i tanti segreti dell’universo.



 Quattro settimane di preparazione, 20 tecnici e operatori specializzati coinvolti, oltre 500 misurazioni registrate attraverso i sensori durante i 92 secondi di accensione che sono serviti a bruciare 36 tonnellate di propellente solido e che hanno generano una spinta 4 volte superiore alla potenza massima del motore di un moderno aereo da trasporto passeggeri. Il test del motore Zefiro 40, che si è concluso con successo nei primi giorni di marzo in Sardegna, è una prova funzionale necessaria a qualificare il nuovo sistema di propulsione. Durante la prova, realizzata a livello del mare, sono stati raccolti tutti i parametri necessari per calcolare il comportamento del motore con un’approssimazione molto vicina alle condizioni reali in cui si troverà a operare lo Z40: l’accensione a circa 50 km dalla superficie della terra nel momento in cui il primo stadio P120 C si sarà sganciato. Il motore Zefiro 40, infatti, è il sistema di propulsione di secondo stadio del Vega C, il nuovo lanciatore europeo di satelliti il cui volo di qualifica è previsto per la fine del 2019. Vega C, evoluzione di Vega, consentirà di aumentare del 60% le prestazioni, portando così il mercato accessibile a questo vettore dal 50% al 90% dei satelliti LEO (Low Earth orbit), una parte consistente dei quali gestita con lanci a carico multiplo.
Quattro settimane di preparazione, 20 tecnici e operatori specializzati coinvolti, oltre 500 misurazioni registrate attraverso i sensori durante i 92 secondi di accensione che sono serviti a bruciare 36 tonnellate di propellente solido e che hanno generano una spinta 4 volte superiore alla potenza massima del motore di un moderno aereo da trasporto passeggeri. Il test del motore Zefiro 40, che si è concluso con successo nei primi giorni di marzo in Sardegna, è una prova funzionale necessaria a qualificare il nuovo sistema di propulsione. Durante la prova, realizzata a livello del mare, sono stati raccolti tutti i parametri necessari per calcolare il comportamento del motore con un’approssimazione molto vicina alle condizioni reali in cui si troverà a operare lo Z40: l’accensione a circa 50 km dalla superficie della terra nel momento in cui il primo stadio P120 C si sarà sganciato. Il motore Zefiro 40, infatti, è il sistema di propulsione di secondo stadio del Vega C, il nuovo lanciatore europeo di satelliti il cui volo di qualifica è previsto per la fine del 2019. Vega C, evoluzione di Vega, consentirà di aumentare del 60% le prestazioni, portando così il mercato accessibile a questo vettore dal 50% al 90% dei satelliti LEO (Low Earth orbit), una parte consistente dei quali gestita con lanci a carico multiplo. 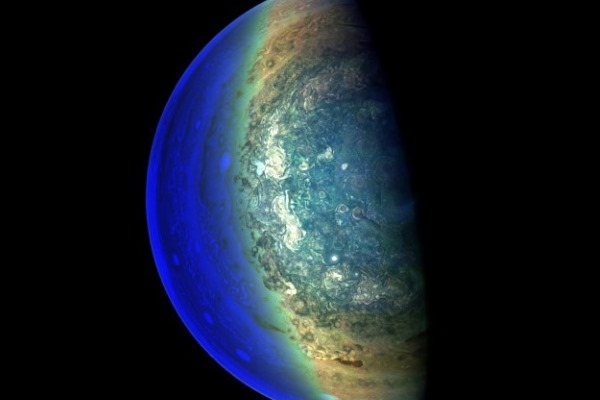
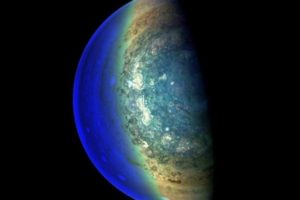

 Thales Alenia Space e Inmarsat, il principale fornitore di comunicazioni satellitari mobili a livello mondiale, lavoreranno insieme all’Agenzia Spaziale Europea sull’innovativo programma Iris che migliorerà la gestione del traffico aereo in Europa. Il programma “Iris with IOC” supporta il masterplan definito in Single European Skies ATM Research (SESAR) e svilupperà servizi di comunicazione satellitare per la gestione del traffico aereo, garantendo lo scambio continuo di informazioni sulla posizione di volo degli aerei e sui punti di navigazione, consentendo ai piloti e ai controllori di volo di definire rotte ottimizzate per quanto riguarda i tempi di volo, il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il programma utilizzerà le soluzioni IP sulla piattaforma SB-S di Inmarsat, già impiegata dalle compagnie aeree, per diminuire la pressione sugli attuali e affollati collegamenti radio in VHF, prossimi alla saturazione. Il progetto avrà una durata di 36 mesi organizzata in due fasi: la prima riguarda la finalizzazione del sistema Iris per fornire il servizio IOC (Initial Operation capability), in linea con gli obiettivi a medio termine dell’iniziativa SESAR della Commissione Europea; a seguire, la definizione del sistema Iris FOC (Full Operational Capability) a supporto di obiettivi di lungo termine di SESAR. Insieme ad Inmarsat, il progetto Iris è guidato dal core team composto da Thales Alenia Space e CGI. Thales Alenia Space sarà principalmente focalizzata sulla definizione del sistema Iris FOC, per il quale l’azienda sarà responsabile della progettazione del segmento spaziale, inclusa la roadmap ed i pre-sviluppi tecnologici. Thales Alenia Space contribuirà inoltre alla definizione ed al progetto di sistema, incluse prestazioni e sicurezza. Iris è l’elemento del programma ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems) di ESA dedicato alla comunicazione satellitare per la gestione del traffico aereo (ATM). Iris supporta il piano generale SESAR – Single European Sky ATM Research – lanciato nel 2006 da EUROCONTROL e dalla Comunità europea. Entro il 2021, Iris IOC fornirà comunicazioni bordo-terra per il controllo iniziale “4D” della rotta, localizzando un aeromobile in quattro dimensioni: latitudine, longitudine, altitudine e tempo. Ciò consentirà di tracciare precisamente i voli ed operare una gestione più efficiente del traffico aereo. I collegamenti via satellite ad alta capacità diventeranno la norma per le operazioni e le comunicazioni vocali saranno impiegate solo per operazioni specifiche ed eccezionali. Entro il 2028, Iris FOC consentirà la piena gestione della traiettoria 4D su spazi aerei in tutto il mondo e il collegamento dati sarà il principale mezzo di comunicazione tra i controllori di volo e gli equipaggi di condotta.
Thales Alenia Space e Inmarsat, il principale fornitore di comunicazioni satellitari mobili a livello mondiale, lavoreranno insieme all’Agenzia Spaziale Europea sull’innovativo programma Iris che migliorerà la gestione del traffico aereo in Europa. Il programma “Iris with IOC” supporta il masterplan definito in Single European Skies ATM Research (SESAR) e svilupperà servizi di comunicazione satellitare per la gestione del traffico aereo, garantendo lo scambio continuo di informazioni sulla posizione di volo degli aerei e sui punti di navigazione, consentendo ai piloti e ai controllori di volo di definire rotte ottimizzate per quanto riguarda i tempi di volo, il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il programma utilizzerà le soluzioni IP sulla piattaforma SB-S di Inmarsat, già impiegata dalle compagnie aeree, per diminuire la pressione sugli attuali e affollati collegamenti radio in VHF, prossimi alla saturazione. Il progetto avrà una durata di 36 mesi organizzata in due fasi: la prima riguarda la finalizzazione del sistema Iris per fornire il servizio IOC (Initial Operation capability), in linea con gli obiettivi a medio termine dell’iniziativa SESAR della Commissione Europea; a seguire, la definizione del sistema Iris FOC (Full Operational Capability) a supporto di obiettivi di lungo termine di SESAR. Insieme ad Inmarsat, il progetto Iris è guidato dal core team composto da Thales Alenia Space e CGI. Thales Alenia Space sarà principalmente focalizzata sulla definizione del sistema Iris FOC, per il quale l’azienda sarà responsabile della progettazione del segmento spaziale, inclusa la roadmap ed i pre-sviluppi tecnologici. Thales Alenia Space contribuirà inoltre alla definizione ed al progetto di sistema, incluse prestazioni e sicurezza. Iris è l’elemento del programma ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems) di ESA dedicato alla comunicazione satellitare per la gestione del traffico aereo (ATM). Iris supporta il piano generale SESAR – Single European Sky ATM Research – lanciato nel 2006 da EUROCONTROL e dalla Comunità europea. Entro il 2021, Iris IOC fornirà comunicazioni bordo-terra per il controllo iniziale “4D” della rotta, localizzando un aeromobile in quattro dimensioni: latitudine, longitudine, altitudine e tempo. Ciò consentirà di tracciare precisamente i voli ed operare una gestione più efficiente del traffico aereo. I collegamenti via satellite ad alta capacità diventeranno la norma per le operazioni e le comunicazioni vocali saranno impiegate solo per operazioni specifiche ed eccezionali. Entro il 2028, Iris FOC consentirà la piena gestione della traiettoria 4D su spazi aerei in tutto il mondo e il collegamento dati sarà il principale mezzo di comunicazione tra i controllori di volo e gli equipaggi di condotta.








