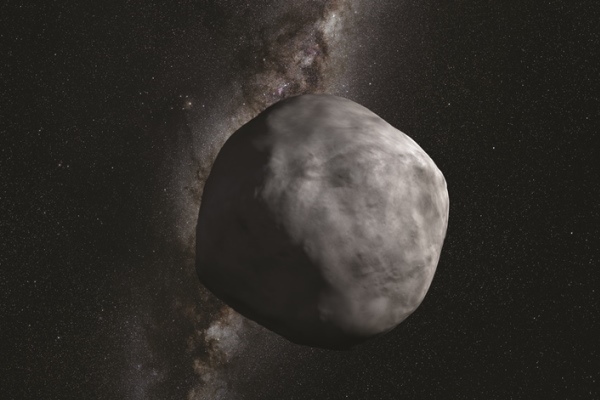
da Sorrentino | Ott 13, 2018 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano
 Osiris-Rex, terza missione del programma Nuove Frontiere della Nasa, che si pone l’obiettivo di prelevare dei campioni dall’asteroide Bennu e riportarli sulla Terra, si avvicina alla fase culminante del viaggio iniziato l’8 settembre 2016. Dopo avere trasmesso il 17 agosto 2018 le prime immagini dell’asteroide, riprese a una distanza di 2,2 milioni di km, quasi sei volte la distanza tra la Terra e la Luna, che ne mostrano il movimento rispetto alle stelle della costellazione del Serpente, la sonda si prepara all’avvicinamento finale previsto il 3 dicembre 2018. Una sfida esaltante, di cui hanno parlato a BergamoScienza tre scienziati italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica coinvolti nel progetto. John Brucato, che lavora all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e si occupa di astrobiologia, fa parte anche del team della missione Exomars 2020; Elisabetta Dotto dell’Osservatorio Astronomico di Roma e Maurizio Pajola ricercatore dell’Osservatorio Astronomico di Padova con esperienze al JPL e al centro Ames della NASA. Va ricordato che un altro italiano, Dante Lauretta dell’Università di Tucson in Arizona, ricopre il ruolo di principal investigator.
Osiris-Rex, terza missione del programma Nuove Frontiere della Nasa, che si pone l’obiettivo di prelevare dei campioni dall’asteroide Bennu e riportarli sulla Terra, si avvicina alla fase culminante del viaggio iniziato l’8 settembre 2016. Dopo avere trasmesso il 17 agosto 2018 le prime immagini dell’asteroide, riprese a una distanza di 2,2 milioni di km, quasi sei volte la distanza tra la Terra e la Luna, che ne mostrano il movimento rispetto alle stelle della costellazione del Serpente, la sonda si prepara all’avvicinamento finale previsto il 3 dicembre 2018. Una sfida esaltante, di cui hanno parlato a BergamoScienza tre scienziati italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica coinvolti nel progetto. John Brucato, che lavora all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e si occupa di astrobiologia, fa parte anche del team della missione Exomars 2020; Elisabetta Dotto dell’Osservatorio Astronomico di Roma e Maurizio Pajola ricercatore dell’Osservatorio Astronomico di Padova con esperienze al JPL e al centro Ames della NASA. Va ricordato che un altro italiano, Dante Lauretta dell’Università di Tucson in Arizona, ricopre il ruolo di principal investigator.
Dopo i successi delle sonde giapponesi Hayabusa, la prima atterrata nel primo decennio sull’asteroide 25143 Itokawa e la seconda che nel settembre 2018 ha fatto posare due piccoli robot sulla superficie dell’asteroide Ryugu distante 300 milioni di chilometri dalla Terra, a sonda Osiris-Rex sarà il primo veicolo spaziale della NASA a visitare un un asteroide vicino alla Terra, ispezionarne la superficie, raccoglierne un campione e riportarlo in sicurezza sul nostro pianeta. Un’operazione la cui complessità è legata all’assenza di un significativo gradiente di gravità (Bennu ha un diametro di appena 500 metri) che consenta il classico ancoraggio in superficie. L’avvicinamento sarà progressivo e il prelievo del materiale superficiale avverrà in pochi secondi con una manovra di tipo aeronautica “touch and go”. La perlustrazione di questi mondi primordiali è fondamentale per conoscerne la composizione chimico-fisica e ricostruire la formazione del sistema solare. La sonda Rosetta, per esempio, ci ha rivelato come la cometa 67P possieda ben 28 unità geologiche. Il ritorno di Osiris-Rex è atteso nel 2023 con il suo prezioso carico che sarà distribuito tra vari laboratori nel mondo. Una parte dei campioni sarà conservata in attesa di strumenti di indagine più evoluti che potranno svelare la natura dell’asteroide. Un po’ come è successo per i campioni riportati sulla Terra dalle missioni Apollo e conservati sotto azoto e ancora oggetto di analisi.
La tabella di avvicinamento all’asteroide ne prevede lo studio attraverso gli strumenti scientifici e riprese fotografiche per rivelarne forma e caratteristiche superficiali. Dal 1° ottobre sono iniziate le manovre destinate a rallentare la velocità di Osiris-rex e permettere l’inserimento nell’orbita di Bennu intorno al Sole. Il piano di volo della sonda prevede una serie di flyby dei poli e dell’equatore di Bennu a distanze comprese tra i 7 e i 19 chilometri. Bennu sarà il più piccolo oggetto attorno al quale qualsiasi veicolo spaziale abbia mai orbitato. Una volta identificate le zone ideali per la raccolta dei campioni, il contatto con la superficie è previsto nel luglio 2020. Quindi, Osiris-Rex farà ritorno verso il nostro pianeta lanciando una capsula contenente i campioni destinata ad atterrare nel deserto dello Utah, nel settembre 2023.
(photo credit: NASA)

da Sorrentino | Ott 11, 2018 | Lanci, Primo Piano, Stazione Spaziale
 L’astronauta americano Nick Hague e il cosmonauta russo Alexey Ovchinin, decollati alle 10:40 ora italiana di giovedì 11 ottobre dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan a bordo della navicella Soyuz MS-10 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, sono stati costretti a un atterraggio di emergenza dopo il malfunzionamento del secondo stadio del razzo vettore verificatosi dopo la separazione del primo stadio. Un calo di spinta che ha fatto abortire la missione e messo in atto la procedura prevista, mai adottata nella storia dei lanci della Soyuz verso la stazione spaziale che aveva registrato sempre il 100 per cento di successo. Il rientro è avvenuto con quello che viene definito “atterraggio balistico” della navicella. Nick Hague e Alexey Ovchinin, dichiarati in buone condizioni e rimasti sempre in contatto con il centro di controllo della missione, sono stati raggiunti dalle squadre di soccorso per essere recuperati e trasportati al Centro di addestramento per i cosmonauti Gagarin alla Città delle Stelle, a circa 20 km da Mosca. NASA e Roscosmos, le agenzie spaziali americana e russa, stanno monitorando la situazione e acquisendo i dati telemetrici che dovranno consentire di stabilire le cause dell’incidente. I due occupanti della capsula non sono stati mai in reale pericolo, avendo messo in atto la procedura di emergenza. Tuttavia, quanto accaduto è da classificare incidente grave e costringerà a rivedere il programma dei lanci verso la stazione spaziale internazionale, a bordo della quale si trovano l’astronauta dell’ESA Alexander Gerst, che conduce la missione Horizons, l’americana Serena Auñón-Chancellor e il comandante Sergej Prokopyev di Roscosmos. La navicella Soyuz è al momento l’unico veicolo in grado di trasferire astronauti sul complesso orbitale, dal momento che Cst-100 Starliner della Boeing e Crew Dragon della SpaceX cominceranno a volare solo nel 2019 e richiedono voli di qualifica. La versione più recente, il modello MS su cui viaggiavano Nick Hague e Alexey Ovchinin, è composta da modulo orbitale, caspula di rientro e modulo di servizio e consente la permanenza a bordo fino a 30 giorni. L’apertura dell’inchiesta e lo stop momentaneo dei lanci costringerò a rivedere i programmi. Potrebbe accusare un ritardo anche ma missione di lunga durata Beyond di Luca Parmitano, annunciata per maggio 2019, quando il nostro astronauta ricoprirà il ruolo di comandante della stazione spaziale.
L’astronauta americano Nick Hague e il cosmonauta russo Alexey Ovchinin, decollati alle 10:40 ora italiana di giovedì 11 ottobre dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan a bordo della navicella Soyuz MS-10 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, sono stati costretti a un atterraggio di emergenza dopo il malfunzionamento del secondo stadio del razzo vettore verificatosi dopo la separazione del primo stadio. Un calo di spinta che ha fatto abortire la missione e messo in atto la procedura prevista, mai adottata nella storia dei lanci della Soyuz verso la stazione spaziale che aveva registrato sempre il 100 per cento di successo. Il rientro è avvenuto con quello che viene definito “atterraggio balistico” della navicella. Nick Hague e Alexey Ovchinin, dichiarati in buone condizioni e rimasti sempre in contatto con il centro di controllo della missione, sono stati raggiunti dalle squadre di soccorso per essere recuperati e trasportati al Centro di addestramento per i cosmonauti Gagarin alla Città delle Stelle, a circa 20 km da Mosca. NASA e Roscosmos, le agenzie spaziali americana e russa, stanno monitorando la situazione e acquisendo i dati telemetrici che dovranno consentire di stabilire le cause dell’incidente. I due occupanti della capsula non sono stati mai in reale pericolo, avendo messo in atto la procedura di emergenza. Tuttavia, quanto accaduto è da classificare incidente grave e costringerà a rivedere il programma dei lanci verso la stazione spaziale internazionale, a bordo della quale si trovano l’astronauta dell’ESA Alexander Gerst, che conduce la missione Horizons, l’americana Serena Auñón-Chancellor e il comandante Sergej Prokopyev di Roscosmos. La navicella Soyuz è al momento l’unico veicolo in grado di trasferire astronauti sul complesso orbitale, dal momento che Cst-100 Starliner della Boeing e Crew Dragon della SpaceX cominceranno a volare solo nel 2019 e richiedono voli di qualifica. La versione più recente, il modello MS su cui viaggiavano Nick Hague e Alexey Ovchinin, è composta da modulo orbitale, caspula di rientro e modulo di servizio e consente la permanenza a bordo fino a 30 giorni. L’apertura dell’inchiesta e lo stop momentaneo dei lanci costringerò a rivedere i programmi. Potrebbe accusare un ritardo anche ma missione di lunga durata Beyond di Luca Parmitano, annunciata per maggio 2019, quando il nostro astronauta ricoprirà il ruolo di comandante della stazione spaziale.

da Sorrentino | Ott 6, 2018 | Eventi Scientifici e Culturali
 Al via sabato 6 ottobre la XVI edizione di BergamoScienza, in programma fino al 21 ottobre con un calendario oltre 160 eventi, che comprendono conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre, tutti fruibili gratuitamente. Una manifestazione che concentra in 16 giorni l’attenzione sul mondo della ricerca, delle tecnologie e del sapere scientifico, attraverso la presenza di esperti e scienziati di fama mondiale, ma che ha sposato l’obiettivo della divulgazione scientifica tutto l’anno coinvolgendo i giovani e le scuole nelle attività che fanno perno sul Bergamo Science Center. L’apertura di BergamoScienza 2018 è stata affidata allo scrittore Ian McEwan e al neuroscienziato Ray Dolan, invitati a diagolare sulle emozioni tra scienza, cervello e letteratura indagando i punti di contatto fra due discipline solo apparentemente distanti. Domenica 7 ottobre alle ore 16, il paleontologo ed esperto di dinosauri Jack Horner, l’Alan Grant di Jurassik Park, consulente di Spielberg e autore della scoperta di nidi fossilizzati di dinosauri, sarà protagonista dell’incontro Riscoprire i dinosauri. Con le sue ricerche, Horner ha dimostrato che questi antichi rettili, da cui discendono i nostri uccelli moderni, accudivano i propri piccoli. Una testimonianza che ricade nella città sede dell’importante Museo di Scienze Naturali, in cui è custodito il calco del rettile volante più antico del mondo e dove è in corso la mostra sui dinosauri procrastinata fino al 6 gennaio 2019. Nel primo weekend di BergamoScienza tiene banco La Scuola in Piazza, kermesse scientifica on the road animata dagli stand di 45 istituti scolastici – dalle scuole d’infanzia all’Università – ai quali si affiancano quelli delle forze dell’ordine: Guardia di Finanza, Accademia della Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Stato Maggiore della Difesa. La Polizia scientifica propone la mostra fotografica Frammenti di storia – l’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi di Polizia scientifica, curata dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Nel secondo weekend di ottobre si parla di spazio con un focus sugli asteroidi, oggetto di studio e potenziali miniere oltre che di costante monitoraggio per il pericolo di impatto con la Terra, e un’analisi dei progetti che mirano a liberare l’orbita terrestre dalla moltitudine di detriti, residuo di sessant’anni di missioni spaziali. (credit immagine: Laura Pietra per BergamoScienza)
Al via sabato 6 ottobre la XVI edizione di BergamoScienza, in programma fino al 21 ottobre con un calendario oltre 160 eventi, che comprendono conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre, tutti fruibili gratuitamente. Una manifestazione che concentra in 16 giorni l’attenzione sul mondo della ricerca, delle tecnologie e del sapere scientifico, attraverso la presenza di esperti e scienziati di fama mondiale, ma che ha sposato l’obiettivo della divulgazione scientifica tutto l’anno coinvolgendo i giovani e le scuole nelle attività che fanno perno sul Bergamo Science Center. L’apertura di BergamoScienza 2018 è stata affidata allo scrittore Ian McEwan e al neuroscienziato Ray Dolan, invitati a diagolare sulle emozioni tra scienza, cervello e letteratura indagando i punti di contatto fra due discipline solo apparentemente distanti. Domenica 7 ottobre alle ore 16, il paleontologo ed esperto di dinosauri Jack Horner, l’Alan Grant di Jurassik Park, consulente di Spielberg e autore della scoperta di nidi fossilizzati di dinosauri, sarà protagonista dell’incontro Riscoprire i dinosauri. Con le sue ricerche, Horner ha dimostrato che questi antichi rettili, da cui discendono i nostri uccelli moderni, accudivano i propri piccoli. Una testimonianza che ricade nella città sede dell’importante Museo di Scienze Naturali, in cui è custodito il calco del rettile volante più antico del mondo e dove è in corso la mostra sui dinosauri procrastinata fino al 6 gennaio 2019. Nel primo weekend di BergamoScienza tiene banco La Scuola in Piazza, kermesse scientifica on the road animata dagli stand di 45 istituti scolastici – dalle scuole d’infanzia all’Università – ai quali si affiancano quelli delle forze dell’ordine: Guardia di Finanza, Accademia della Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Stato Maggiore della Difesa. La Polizia scientifica propone la mostra fotografica Frammenti di storia – l’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi di Polizia scientifica, curata dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Nel secondo weekend di ottobre si parla di spazio con un focus sugli asteroidi, oggetto di studio e potenziali miniere oltre che di costante monitoraggio per il pericolo di impatto con la Terra, e un’analisi dei progetti che mirano a liberare l’orbita terrestre dalla moltitudine di detriti, residuo di sessant’anni di missioni spaziali. (credit immagine: Laura Pietra per BergamoScienza)

da Sorrentino | Ott 4, 2018 | Astronomia, Industria, Primo Piano, Programmi
 Thales Alenia Space ha siglato con OHB un contratto per il nuovo programma Plato dell’Agenzia Spaziale Europea, finalizzato a scoprire sistemi planetari extrasolari potenzialmente abitabili. OHB System AG sarà prime contractor e Thales Alenia Space partner del progetto. L’accordo è stato sottoscritto durante la 69esima edizione del Congresso Internazionale di Astronautica ospitato a Brema. PLATO sarà la terza missione scientifica di classe media nell’ambito del programma Cosmic Vision, segue Solar Orbiter e Euclid e precede Ariel (M4). Il satellite sarà lanciato nel 2026 con una missione iniziale prevista di quattro anni e mezzo. Obiettivo di PLATO è scoprire sistemi planetari extrasolari e, in modo particolare, pianeti simili alla Terra nelle zone abitabili (compatibili con acqua allo stato liquido) vicino a stelle come il nostro Sole. A differenza delle missioni che l’hanno preceduta, CoRot e Kepler, PLATO offrirà un’opportunità unica di condurre osservazioni stabili e ad ampio campo su un arco di tempo molto lungo (da due a quattro anni), consentendoci di individuare e di caratterizzare pianeti che orbitano intorno al sole lentamente, proprio come la Terra. Il satellite verrà posto in orbita intorno al punto di Lagrange L2 con un payload scientifico di 26 fotocamere e le relative componenti elettroniche. Thales Alenia Space (France e UK) si occuperà dell’avionica e dell’integrazione del modulo di servizio (SVM), i cui test saranno eseguiti e integrati nel sito di Thales Alenia Space a Cannes, con grande coinvolgimento dei team Thales Alenia Space del Regno Unito. Le unità ottiche dei 26 telescopi di PLATO sono nate, grazie al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, nei laboratori INAF e saranno costruite a Campi Bisenzio da Leonardo con la collaborazione dell’Università di Berna, di Thales Alenia Space e Medialario, e saranno poi consegnate al centro spaziale di OHB “Optics & Science” a Oberpfaffenhofen, vicino a Monaco. Qui verranno svolte, in una camera pulita di classe 5, le attività di integrazione degli strumenti.
Thales Alenia Space ha siglato con OHB un contratto per il nuovo programma Plato dell’Agenzia Spaziale Europea, finalizzato a scoprire sistemi planetari extrasolari potenzialmente abitabili. OHB System AG sarà prime contractor e Thales Alenia Space partner del progetto. L’accordo è stato sottoscritto durante la 69esima edizione del Congresso Internazionale di Astronautica ospitato a Brema. PLATO sarà la terza missione scientifica di classe media nell’ambito del programma Cosmic Vision, segue Solar Orbiter e Euclid e precede Ariel (M4). Il satellite sarà lanciato nel 2026 con una missione iniziale prevista di quattro anni e mezzo. Obiettivo di PLATO è scoprire sistemi planetari extrasolari e, in modo particolare, pianeti simili alla Terra nelle zone abitabili (compatibili con acqua allo stato liquido) vicino a stelle come il nostro Sole. A differenza delle missioni che l’hanno preceduta, CoRot e Kepler, PLATO offrirà un’opportunità unica di condurre osservazioni stabili e ad ampio campo su un arco di tempo molto lungo (da due a quattro anni), consentendoci di individuare e di caratterizzare pianeti che orbitano intorno al sole lentamente, proprio come la Terra. Il satellite verrà posto in orbita intorno al punto di Lagrange L2 con un payload scientifico di 26 fotocamere e le relative componenti elettroniche. Thales Alenia Space (France e UK) si occuperà dell’avionica e dell’integrazione del modulo di servizio (SVM), i cui test saranno eseguiti e integrati nel sito di Thales Alenia Space a Cannes, con grande coinvolgimento dei team Thales Alenia Space del Regno Unito. Le unità ottiche dei 26 telescopi di PLATO sono nate, grazie al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, nei laboratori INAF e saranno costruite a Campi Bisenzio da Leonardo con la collaborazione dell’Università di Berna, di Thales Alenia Space e Medialario, e saranno poi consegnate al centro spaziale di OHB “Optics & Science” a Oberpfaffenhofen, vicino a Monaco. Qui verranno svolte, in una camera pulita di classe 5, le attività di integrazione degli strumenti.
Donato Amoroso, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia, ha espresso viva soddisfazione per il varo della partnership con OHB nello sviluppo e nell’ assemblaggio di questo nuovo satellite scientifico per ESA, sottolineando che “il programma PLATO sarà il risultato delle competenze nel campo dell’avionica, già impiegate nei nostri satelliti di Telecomunicazioni e Osservazione della Terra, e delle conoscenze acquisite su altre missioni L2, ovvero Herschel-Planck e Euclid”.

da Sorrentino | Set 27, 2018 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale
 L’Agenzia Spaziale Europea ha reso noto il titolo della missione che sarà condotta dall’astronauta italiano Luca Parmitano nel 2019. L’annuncio è avvenuto nella sede dell’Esrin a Frascati, nel giorno del 38esimo compleanno di AstroLuca. La missione si chiamerà “Beyond”, ovvero “Oltre”, un chiaro riferimento a quanto attende Parmitano in termini di esperimenti e attività di ricerca fisiologica nella sua seconda missione a lungo termine a bordo della stazione spaziale internazionale, di cui assumerà il comando per un periodo di tre mesi, nel corso della seconda parte della missione, che condurrà insieme a Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Parmitano sarà il primo italiano al comando della ISS, il terzo degli astronauti europei. Nel corso della sua prima esperienza in orbita, Luca Parmitano ha effettuato sei ore e 7 minuti di attività extraveicolare, uscendo due volte, la seconda conclusasi con il rientro anticipato e precipitoso causa una perdita all’interno della tuta che inondò il casco di un litro e mezzo di acqua rischiando di farlo annegare. Proprio a questa esperienza, datata 16 luglio 2013, è dedicato il film-documentario EVA23 che l’Agenzia Spaziale Italiana ha deciso di proiettare nell’auditorium della propria sede a Roma, alla presenza del regista e produttore del film Marc Havican e dello stesso Luca Parmitano.
L’Agenzia Spaziale Europea ha reso noto il titolo della missione che sarà condotta dall’astronauta italiano Luca Parmitano nel 2019. L’annuncio è avvenuto nella sede dell’Esrin a Frascati, nel giorno del 38esimo compleanno di AstroLuca. La missione si chiamerà “Beyond”, ovvero “Oltre”, un chiaro riferimento a quanto attende Parmitano in termini di esperimenti e attività di ricerca fisiologica nella sua seconda missione a lungo termine a bordo della stazione spaziale internazionale, di cui assumerà il comando per un periodo di tre mesi, nel corso della seconda parte della missione, che condurrà insieme a Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Parmitano sarà il primo italiano al comando della ISS, il terzo degli astronauti europei. Nel corso della sua prima esperienza in orbita, Luca Parmitano ha effettuato sei ore e 7 minuti di attività extraveicolare, uscendo due volte, la seconda conclusasi con il rientro anticipato e precipitoso causa una perdita all’interno della tuta che inondò il casco di un litro e mezzo di acqua rischiando di farlo annegare. Proprio a questa esperienza, datata 16 luglio 2013, è dedicato il film-documentario EVA23 che l’Agenzia Spaziale Italiana ha deciso di proiettare nell’auditorium della propria sede a Roma, alla presenza del regista e produttore del film Marc Havican e dello stesso Luca Parmitano.
Il docufilm racconta come la difficile situazione potè risolversi grazie al sangue freddo di AstroLuca e al duro addestramento che ha seguito da militare prima e da astronauta poi, riuscì a gestire la situazione nel migliore dei modi e a rientrare nella ISS. EVA 23 è il racconto di una vicenda che spinge ad essere seguita per capire esattamente come andarono le cose durante quell’evento. Il 16 luglio 2013 Luca aveva in programma la seconda attività extraveicolare della missione “Volare”. Dopo circa 30 minuti l’acqua iniziò a riempire il casco pressurizzato, prima bagnandogli la nuca, poi arrivando alle orecchie, tanto da rendere difficoltoso sentire le comunicazioni del Centro di Controllo. Nel giro di pochi minuti arrivò a un livello tale da rischiare di impedire a Luca di respirare e di vedere attorno a lui. La spiegazione tecnica dell’accaduto fu inclusa in 222 pagine del rapporto ufficiale, in cui si legge che il problema fu originato da un guasto a una valvola meccanica, che impedì all’acqua di circolare correttamente convogliandola nel circuito dell’aria. Un problema che diede le prime avvisaglie già nella prima attività extraveicolare di Luca, la EVA 22 di qualche giorno prima, e che fu erroneamente imputato alla sacca di riserva dell’acqua. Rimpiazzata la sacca, l’astronauta riusò la tuta per la seconda volta. Nella EVA 23 non solo il problema si ripresentò, ma rischiò di costare la vita all’astronauta. In quei momenti drammatici nemmeno al centro di controllo si pensò a un guasto alla valvola, o al fatto che l’acqua in condizioni di assenza di peso avrebbe avvolto la testa dell’astronauta. La fisica dei liquidi nello Spazio, pure essendo nota, non fu applicata a quella particolare circostanza. Non sapendo come gestire l’emergenza, l’unico ordine che arrivò fu quello di rientrare nella ISS. Luca Parmitano comprese la gravità della situazione e fu capace di gestirla, tanto che la commissione d’indagine scrisse che “il comportamento lucido e pacato davanti all’allagamento del suo casco ha probabilmente salvato la vita dell’astronauta”. Gli errori che condussero all’incidente e alla sua gestione furono dovuti al fatto che non era mai accaduto nulla di simile in passato, e nessuno aveva messo in preventivo che sarebbe potuto accadere, tanto che non era mai stato simulato a Terra un guasto di questo tipo.
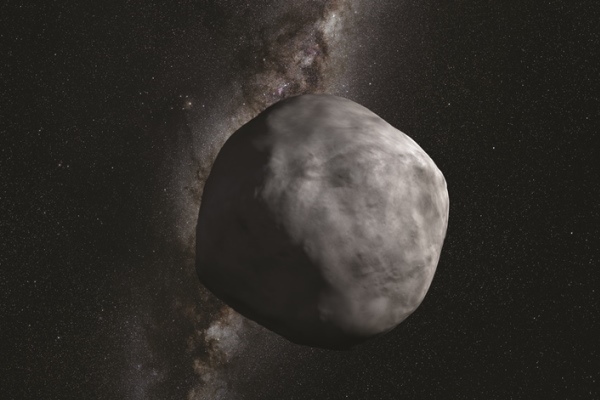
 Osiris-Rex, terza missione del programma Nuove Frontiere della Nasa, che si pone l’obiettivo di prelevare dei campioni dall’asteroide Bennu e riportarli sulla Terra, si avvicina alla fase culminante del viaggio iniziato l’8 settembre 2016. Dopo avere trasmesso il 17 agosto 2018 le prime immagini dell’asteroide, riprese a una distanza di 2,2 milioni di km, quasi sei volte la distanza tra la Terra e la Luna, che ne mostrano il movimento rispetto alle stelle della costellazione del Serpente, la sonda si prepara all’avvicinamento finale previsto il 3 dicembre 2018. Una sfida esaltante, di cui hanno parlato a BergamoScienza tre scienziati italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica coinvolti nel progetto. John Brucato, che lavora all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e si occupa di astrobiologia, fa parte anche del team della missione Exomars 2020; Elisabetta Dotto dell’Osservatorio Astronomico di Roma e Maurizio Pajola ricercatore dell’Osservatorio Astronomico di Padova con esperienze al JPL e al centro Ames della NASA. Va ricordato che un altro italiano, Dante Lauretta dell’Università di Tucson in Arizona, ricopre il ruolo di principal investigator.
Osiris-Rex, terza missione del programma Nuove Frontiere della Nasa, che si pone l’obiettivo di prelevare dei campioni dall’asteroide Bennu e riportarli sulla Terra, si avvicina alla fase culminante del viaggio iniziato l’8 settembre 2016. Dopo avere trasmesso il 17 agosto 2018 le prime immagini dell’asteroide, riprese a una distanza di 2,2 milioni di km, quasi sei volte la distanza tra la Terra e la Luna, che ne mostrano il movimento rispetto alle stelle della costellazione del Serpente, la sonda si prepara all’avvicinamento finale previsto il 3 dicembre 2018. Una sfida esaltante, di cui hanno parlato a BergamoScienza tre scienziati italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica coinvolti nel progetto. John Brucato, che lavora all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e si occupa di astrobiologia, fa parte anche del team della missione Exomars 2020; Elisabetta Dotto dell’Osservatorio Astronomico di Roma e Maurizio Pajola ricercatore dell’Osservatorio Astronomico di Padova con esperienze al JPL e al centro Ames della NASA. Va ricordato che un altro italiano, Dante Lauretta dell’Università di Tucson in Arizona, ricopre il ruolo di principal investigator.
 L’astronauta americano Nick Hague e il cosmonauta russo Alexey Ovchinin, decollati alle 10:40 ora italiana di giovedì 11 ottobre dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan a bordo della navicella Soyuz MS-10 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, sono stati costretti a un atterraggio di emergenza dopo il malfunzionamento del secondo stadio del razzo vettore verificatosi dopo la separazione del primo stadio. Un calo di spinta che ha fatto abortire la missione e messo in atto la procedura prevista, mai adottata nella storia dei lanci della Soyuz verso la stazione spaziale che aveva registrato sempre il 100 per cento di successo. Il rientro è avvenuto con quello che viene definito “atterraggio balistico” della navicella. Nick Hague e Alexey Ovchinin, dichiarati in buone condizioni e rimasti sempre in contatto con il centro di controllo della missione, sono stati raggiunti dalle squadre di soccorso per essere recuperati e trasportati al Centro di addestramento per i cosmonauti Gagarin alla Città delle Stelle, a circa 20 km da Mosca. NASA e Roscosmos, le agenzie spaziali americana e russa, stanno monitorando la situazione e acquisendo i dati telemetrici che dovranno consentire di stabilire le cause dell’incidente. I due occupanti della capsula non sono stati mai in reale pericolo, avendo messo in atto la procedura di emergenza. Tuttavia, quanto accaduto è da classificare incidente grave e costringerà a rivedere il programma dei lanci verso la stazione spaziale internazionale, a bordo della quale si trovano l’astronauta dell’ESA Alexander Gerst, che conduce la missione Horizons, l’americana Serena Auñón-Chancellor e il comandante Sergej Prokopyev di Roscosmos. La navicella Soyuz è al momento l’unico veicolo in grado di trasferire astronauti sul complesso orbitale, dal momento che Cst-100 Starliner della Boeing e Crew Dragon della SpaceX cominceranno a volare solo nel 2019 e richiedono voli di qualifica. La versione più recente, il modello MS su cui viaggiavano Nick Hague e Alexey Ovchinin, è composta da modulo orbitale, caspula di rientro e modulo di servizio e consente la permanenza a bordo fino a 30 giorni. L’apertura dell’inchiesta e lo stop momentaneo dei lanci costringerò a rivedere i programmi. Potrebbe accusare un ritardo anche ma missione di lunga durata Beyond di Luca Parmitano, annunciata per maggio 2019, quando il nostro astronauta ricoprirà il ruolo di comandante della stazione spaziale.
L’astronauta americano Nick Hague e il cosmonauta russo Alexey Ovchinin, decollati alle 10:40 ora italiana di giovedì 11 ottobre dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan a bordo della navicella Soyuz MS-10 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, sono stati costretti a un atterraggio di emergenza dopo il malfunzionamento del secondo stadio del razzo vettore verificatosi dopo la separazione del primo stadio. Un calo di spinta che ha fatto abortire la missione e messo in atto la procedura prevista, mai adottata nella storia dei lanci della Soyuz verso la stazione spaziale che aveva registrato sempre il 100 per cento di successo. Il rientro è avvenuto con quello che viene definito “atterraggio balistico” della navicella. Nick Hague e Alexey Ovchinin, dichiarati in buone condizioni e rimasti sempre in contatto con il centro di controllo della missione, sono stati raggiunti dalle squadre di soccorso per essere recuperati e trasportati al Centro di addestramento per i cosmonauti Gagarin alla Città delle Stelle, a circa 20 km da Mosca. NASA e Roscosmos, le agenzie spaziali americana e russa, stanno monitorando la situazione e acquisendo i dati telemetrici che dovranno consentire di stabilire le cause dell’incidente. I due occupanti della capsula non sono stati mai in reale pericolo, avendo messo in atto la procedura di emergenza. Tuttavia, quanto accaduto è da classificare incidente grave e costringerà a rivedere il programma dei lanci verso la stazione spaziale internazionale, a bordo della quale si trovano l’astronauta dell’ESA Alexander Gerst, che conduce la missione Horizons, l’americana Serena Auñón-Chancellor e il comandante Sergej Prokopyev di Roscosmos. La navicella Soyuz è al momento l’unico veicolo in grado di trasferire astronauti sul complesso orbitale, dal momento che Cst-100 Starliner della Boeing e Crew Dragon della SpaceX cominceranno a volare solo nel 2019 e richiedono voli di qualifica. La versione più recente, il modello MS su cui viaggiavano Nick Hague e Alexey Ovchinin, è composta da modulo orbitale, caspula di rientro e modulo di servizio e consente la permanenza a bordo fino a 30 giorni. L’apertura dell’inchiesta e lo stop momentaneo dei lanci costringerò a rivedere i programmi. Potrebbe accusare un ritardo anche ma missione di lunga durata Beyond di Luca Parmitano, annunciata per maggio 2019, quando il nostro astronauta ricoprirà il ruolo di comandante della stazione spaziale.
 Al via sabato 6 ottobre la XVI edizione di BergamoScienza, in programma fino al 21 ottobre con un calendario oltre 160 eventi, che comprendono conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre, tutti fruibili gratuitamente. Una manifestazione che concentra in 16 giorni l’attenzione sul mondo della ricerca, delle tecnologie e del sapere scientifico, attraverso la presenza di esperti e scienziati di fama mondiale, ma che ha sposato l’obiettivo della divulgazione scientifica tutto l’anno coinvolgendo i giovani e le scuole nelle attività che fanno perno sul Bergamo Science Center. L’apertura di BergamoScienza 2018 è stata affidata allo scrittore Ian McEwan e al neuroscienziato Ray Dolan, invitati a diagolare sulle emozioni tra scienza, cervello e letteratura indagando i punti di contatto fra due discipline solo apparentemente distanti. Domenica 7 ottobre alle ore 16, il paleontologo ed esperto di dinosauri Jack Horner, l’Alan Grant di Jurassik Park, consulente di Spielberg e autore della scoperta di nidi fossilizzati di dinosauri, sarà protagonista dell’incontro Riscoprire i dinosauri. Con le sue ricerche, Horner ha dimostrato che questi antichi rettili, da cui discendono i nostri uccelli moderni, accudivano i propri piccoli. Una testimonianza che ricade nella città sede dell’importante Museo di Scienze Naturali, in cui è custodito il calco del rettile volante più antico del mondo e dove è in corso la mostra sui dinosauri procrastinata fino al 6 gennaio 2019. Nel primo weekend di BergamoScienza tiene banco La Scuola in Piazza, kermesse scientifica on the road animata dagli stand di 45 istituti scolastici – dalle scuole d’infanzia all’Università – ai quali si affiancano quelli delle forze dell’ordine: Guardia di Finanza, Accademia della Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Stato Maggiore della Difesa. La Polizia scientifica propone la mostra fotografica Frammenti di storia – l’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi di Polizia scientifica, curata dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Nel secondo weekend di ottobre si parla di spazio con un focus sugli asteroidi, oggetto di studio e potenziali miniere oltre che di costante monitoraggio per il pericolo di impatto con la Terra, e un’analisi dei progetti che mirano a liberare l’orbita terrestre dalla moltitudine di detriti, residuo di sessant’anni di missioni spaziali. (credit immagine: Laura Pietra per BergamoScienza)
Al via sabato 6 ottobre la XVI edizione di BergamoScienza, in programma fino al 21 ottobre con un calendario oltre 160 eventi, che comprendono conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre, tutti fruibili gratuitamente. Una manifestazione che concentra in 16 giorni l’attenzione sul mondo della ricerca, delle tecnologie e del sapere scientifico, attraverso la presenza di esperti e scienziati di fama mondiale, ma che ha sposato l’obiettivo della divulgazione scientifica tutto l’anno coinvolgendo i giovani e le scuole nelle attività che fanno perno sul Bergamo Science Center. L’apertura di BergamoScienza 2018 è stata affidata allo scrittore Ian McEwan e al neuroscienziato Ray Dolan, invitati a diagolare sulle emozioni tra scienza, cervello e letteratura indagando i punti di contatto fra due discipline solo apparentemente distanti. Domenica 7 ottobre alle ore 16, il paleontologo ed esperto di dinosauri Jack Horner, l’Alan Grant di Jurassik Park, consulente di Spielberg e autore della scoperta di nidi fossilizzati di dinosauri, sarà protagonista dell’incontro Riscoprire i dinosauri. Con le sue ricerche, Horner ha dimostrato che questi antichi rettili, da cui discendono i nostri uccelli moderni, accudivano i propri piccoli. Una testimonianza che ricade nella città sede dell’importante Museo di Scienze Naturali, in cui è custodito il calco del rettile volante più antico del mondo e dove è in corso la mostra sui dinosauri procrastinata fino al 6 gennaio 2019. Nel primo weekend di BergamoScienza tiene banco La Scuola in Piazza, kermesse scientifica on the road animata dagli stand di 45 istituti scolastici – dalle scuole d’infanzia all’Università – ai quali si affiancano quelli delle forze dell’ordine: Guardia di Finanza, Accademia della Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Stato Maggiore della Difesa. La Polizia scientifica propone la mostra fotografica Frammenti di storia – l’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi di Polizia scientifica, curata dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Nel secondo weekend di ottobre si parla di spazio con un focus sugli asteroidi, oggetto di studio e potenziali miniere oltre che di costante monitoraggio per il pericolo di impatto con la Terra, e un’analisi dei progetti che mirano a liberare l’orbita terrestre dalla moltitudine di detriti, residuo di sessant’anni di missioni spaziali. (credit immagine: Laura Pietra per BergamoScienza)
 Thales Alenia Space ha siglato con OHB un contratto per il nuovo programma Plato dell’Agenzia Spaziale Europea, finalizzato a scoprire sistemi planetari extrasolari potenzialmente abitabili. OHB System AG sarà prime contractor e Thales Alenia Space partner del progetto. L’accordo è stato sottoscritto durante la 69esima edizione del Congresso Internazionale di Astronautica ospitato a Brema. PLATO sarà la terza missione scientifica di classe media nell’ambito del programma Cosmic Vision, segue Solar Orbiter e Euclid e precede Ariel (M4). Il satellite sarà lanciato nel 2026 con una missione iniziale prevista di quattro anni e mezzo. Obiettivo di PLATO è scoprire sistemi planetari extrasolari e, in modo particolare, pianeti simili alla Terra nelle zone abitabili (compatibili con acqua allo stato liquido) vicino a stelle come il nostro Sole. A differenza delle missioni che l’hanno preceduta, CoRot e Kepler, PLATO offrirà un’opportunità unica di condurre osservazioni stabili e ad ampio campo su un arco di tempo molto lungo (da due a quattro anni), consentendoci di individuare e di caratterizzare pianeti che orbitano intorno al sole lentamente, proprio come la Terra. Il satellite verrà posto in orbita intorno al punto di Lagrange L2 con un payload scientifico di 26 fotocamere e le relative componenti elettroniche. Thales Alenia Space (France e UK) si occuperà dell’avionica e dell’integrazione del modulo di servizio (SVM), i cui test saranno eseguiti e integrati nel sito di Thales Alenia Space a Cannes, con grande coinvolgimento dei team Thales Alenia Space del Regno Unito. Le unità ottiche dei 26 telescopi di PLATO sono nate, grazie al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, nei laboratori INAF e saranno costruite a Campi Bisenzio da Leonardo con la collaborazione dell’Università di Berna, di Thales Alenia Space e Medialario, e saranno poi consegnate al centro spaziale di OHB “Optics & Science” a Oberpfaffenhofen, vicino a Monaco. Qui verranno svolte, in una camera pulita di classe 5, le attività di integrazione degli strumenti.
Thales Alenia Space ha siglato con OHB un contratto per il nuovo programma Plato dell’Agenzia Spaziale Europea, finalizzato a scoprire sistemi planetari extrasolari potenzialmente abitabili. OHB System AG sarà prime contractor e Thales Alenia Space partner del progetto. L’accordo è stato sottoscritto durante la 69esima edizione del Congresso Internazionale di Astronautica ospitato a Brema. PLATO sarà la terza missione scientifica di classe media nell’ambito del programma Cosmic Vision, segue Solar Orbiter e Euclid e precede Ariel (M4). Il satellite sarà lanciato nel 2026 con una missione iniziale prevista di quattro anni e mezzo. Obiettivo di PLATO è scoprire sistemi planetari extrasolari e, in modo particolare, pianeti simili alla Terra nelle zone abitabili (compatibili con acqua allo stato liquido) vicino a stelle come il nostro Sole. A differenza delle missioni che l’hanno preceduta, CoRot e Kepler, PLATO offrirà un’opportunità unica di condurre osservazioni stabili e ad ampio campo su un arco di tempo molto lungo (da due a quattro anni), consentendoci di individuare e di caratterizzare pianeti che orbitano intorno al sole lentamente, proprio come la Terra. Il satellite verrà posto in orbita intorno al punto di Lagrange L2 con un payload scientifico di 26 fotocamere e le relative componenti elettroniche. Thales Alenia Space (France e UK) si occuperà dell’avionica e dell’integrazione del modulo di servizio (SVM), i cui test saranno eseguiti e integrati nel sito di Thales Alenia Space a Cannes, con grande coinvolgimento dei team Thales Alenia Space del Regno Unito. Le unità ottiche dei 26 telescopi di PLATO sono nate, grazie al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, nei laboratori INAF e saranno costruite a Campi Bisenzio da Leonardo con la collaborazione dell’Università di Berna, di Thales Alenia Space e Medialario, e saranno poi consegnate al centro spaziale di OHB “Optics & Science” a Oberpfaffenhofen, vicino a Monaco. Qui verranno svolte, in una camera pulita di classe 5, le attività di integrazione degli strumenti.
 L’Agenzia Spaziale Europea ha reso noto il titolo della missione che sarà condotta dall’astronauta italiano Luca Parmitano nel 2019. L’annuncio è avvenuto nella sede dell’Esrin a Frascati, nel giorno del 38esimo compleanno di AstroLuca. La missione si chiamerà “Beyond”, ovvero “Oltre”, un chiaro riferimento a quanto attende Parmitano in termini di esperimenti e attività di ricerca fisiologica nella sua seconda missione a lungo termine a bordo della stazione spaziale internazionale, di cui assumerà il comando per un periodo di tre mesi, nel corso della seconda parte della missione, che condurrà insieme a Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Parmitano sarà il primo italiano al comando della ISS, il terzo degli astronauti europei. Nel corso della sua prima esperienza in orbita, Luca Parmitano ha effettuato sei ore e 7 minuti di attività extraveicolare, uscendo due volte, la seconda conclusasi con il rientro anticipato e precipitoso causa una perdita all’interno della tuta che inondò il casco di un litro e mezzo di acqua rischiando di farlo annegare. Proprio a questa esperienza, datata 16 luglio 2013, è dedicato il film-documentario EVA23 che l’Agenzia Spaziale Italiana ha deciso di proiettare nell’auditorium della propria sede a Roma, alla presenza del regista e produttore del film Marc Havican e dello stesso Luca Parmitano.
L’Agenzia Spaziale Europea ha reso noto il titolo della missione che sarà condotta dall’astronauta italiano Luca Parmitano nel 2019. L’annuncio è avvenuto nella sede dell’Esrin a Frascati, nel giorno del 38esimo compleanno di AstroLuca. La missione si chiamerà “Beyond”, ovvero “Oltre”, un chiaro riferimento a quanto attende Parmitano in termini di esperimenti e attività di ricerca fisiologica nella sua seconda missione a lungo termine a bordo della stazione spaziale internazionale, di cui assumerà il comando per un periodo di tre mesi, nel corso della seconda parte della missione, che condurrà insieme a Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Parmitano sarà il primo italiano al comando della ISS, il terzo degli astronauti europei. Nel corso della sua prima esperienza in orbita, Luca Parmitano ha effettuato sei ore e 7 minuti di attività extraveicolare, uscendo due volte, la seconda conclusasi con il rientro anticipato e precipitoso causa una perdita all’interno della tuta che inondò il casco di un litro e mezzo di acqua rischiando di farlo annegare. Proprio a questa esperienza, datata 16 luglio 2013, è dedicato il film-documentario EVA23 che l’Agenzia Spaziale Italiana ha deciso di proiettare nell’auditorium della propria sede a Roma, alla presenza del regista e produttore del film Marc Havican e dello stesso Luca Parmitano.








