
da Sorrentino | Giu 25, 2019 | Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari
 Ennesimo esame superato per SpaceX che ha effettuato un lancio notturno con il potente razzo Falcon Heay, alla sua terza missione denominata “Space Test Program-2 (STP-2), lo stesso che nel 2018 accompagnò il viaggio di una Tesla Roadstar verso Marte. A bordo 24 satellite da posizione in tre orbite diverse durante le sei ore successive alla partenza da Cape Canaveral, avvenuta quando in Italia erano le 8.28 del mattino. L’operazione di rilascio in tempi e a quote orbitali differenti del carico utile è stata prevista mediante quattro accensioni del secondo stadio del Falcon Heavy. Come da programma, SpaceX ha recuperato e fatto riatterrare sulla piattaforma del centro spaziale in Florida i due booster del razzo vettore, che hanno toccato terra in verticale rispettivamente 8’45” e 11’15” dopo il lancio. Il carico utile per complessivi 3,7 tonnellate comprende una serie di strumentazioni ed esperimenti scientifici della NASA, del NOAA, dell’Aeronautica militare statunitense, e quelli messi a punto da università e piccole compagnie spaziali private. Tra gli utenti privati figura anche Celestis, azienda specializzata nel lancio di ceneri umane nello Spazio, che ha trasferito in orbita, all’interno della capsula Orbital Test Bed (in cui peraltro la NASA ha posizionato l’orologio atomico miniaturizzato Deep Space Atomic Clock,, le urne con le cremazioni di 152 persone, comprese quelle dell’astronauta americano Bill Pogue, protagonista di una missione di 84 giorni a bordo dello Skylab negli anni ’70. Heritage Flight, questo il nome del carico dell’ultimo viaggio, resterà in orbita 25 anni prima di ricadere e bruciare dissolvendosi nell’atmosfera terreste. La parte scientifica più interessante è legata alla Planetary Society, che ha lanciato LightSail 2, un piccolo satellite che una volta in orbita dispiegherà una vela solare. Un programma sostenuto da crowfunding che permetterà di testare i vantaggi della spinta prodotti dai fotoni per viaggiare nel sistema solare senza ausilio di motori e pannelli solari.
Ennesimo esame superato per SpaceX che ha effettuato un lancio notturno con il potente razzo Falcon Heay, alla sua terza missione denominata “Space Test Program-2 (STP-2), lo stesso che nel 2018 accompagnò il viaggio di una Tesla Roadstar verso Marte. A bordo 24 satellite da posizione in tre orbite diverse durante le sei ore successive alla partenza da Cape Canaveral, avvenuta quando in Italia erano le 8.28 del mattino. L’operazione di rilascio in tempi e a quote orbitali differenti del carico utile è stata prevista mediante quattro accensioni del secondo stadio del Falcon Heavy. Come da programma, SpaceX ha recuperato e fatto riatterrare sulla piattaforma del centro spaziale in Florida i due booster del razzo vettore, che hanno toccato terra in verticale rispettivamente 8’45” e 11’15” dopo il lancio. Il carico utile per complessivi 3,7 tonnellate comprende una serie di strumentazioni ed esperimenti scientifici della NASA, del NOAA, dell’Aeronautica militare statunitense, e quelli messi a punto da università e piccole compagnie spaziali private. Tra gli utenti privati figura anche Celestis, azienda specializzata nel lancio di ceneri umane nello Spazio, che ha trasferito in orbita, all’interno della capsula Orbital Test Bed (in cui peraltro la NASA ha posizionato l’orologio atomico miniaturizzato Deep Space Atomic Clock,, le urne con le cremazioni di 152 persone, comprese quelle dell’astronauta americano Bill Pogue, protagonista di una missione di 84 giorni a bordo dello Skylab negli anni ’70. Heritage Flight, questo il nome del carico dell’ultimo viaggio, resterà in orbita 25 anni prima di ricadere e bruciare dissolvendosi nell’atmosfera terreste. La parte scientifica più interessante è legata alla Planetary Society, che ha lanciato LightSail 2, un piccolo satellite che una volta in orbita dispiegherà una vela solare. Un programma sostenuto da crowfunding che permetterà di testare i vantaggi della spinta prodotti dai fotoni per viaggiare nel sistema solare senza ausilio di motori e pannelli solari.

da Sorrentino | Giu 21, 2019 | Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari

Il satellite per le telecomunicazioni T-16 realizzato da Airbus è stato lanciato con successo da Kourou, nella Guyana francese, tramite il lanciatore Ariane 5. T-16 è basato sulla piattaforma geostazionaria Eurostar E3000 di Airbus, estremamente affidabile, ed è il 50° satellite di questo tipo a essere lanciato. Fornirà una capacità satellitare ad alta potenza per i servizi di trasmissione televisiva ad alta disponibilità, incluso il superamento dell’effetto “rain fade”.
Una volta separato dal lanciatore, il satellite Eurostar E3000 utilizzerà il proprio sistema di propulsione chimica per raggiungere l’orbita geostazionaria, cosa che richiederà circa una settimana. Il T-16 fornirà servizi di trasmissione ad alta potenza in bande Ku, Ka e Reverse. Grazie alla sua flessibilità, il satellite può essere utilizzato su cinque diversi slot orbitali (da 99° Ovest a 119° Ovest) e coprirà gli Stati Uniti continentali, l’Alaska, le Hawaii e Porto Rico. Con una massa al lancio di 6.330 kg e una potenza di 18 kW, il satellite è progettato per svolgere un servizio in orbita della durata di 15 anni

da Sorrentino | Mag 20, 2019 | Lanci, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari
 Il razzo vettore Falcon 9 di SpaceX, con a bordo i primi 60 satelliti della costellazione Starlink, ideata da Elon Musk per offrire servizi di comunicazione internet ad alta velocità su banda larga in orbita bassa, effettuerà un terzo tentativo di lancio giovedì 23 maggio partendo da Cape Canaveral. A un primo rinvio del lift-off, causa forte vento in quota mercoledì 15 maggio, ne era seguito un secondo imposto dalla necessità di aggiornare il software che gestisce le operazioni di rilascio del carico utile. Il gruppo di 60 satelliti, ciascuno del peso di 227 kg e a forma di pannelli piatti dotati di antenne ad alta potenza di trasmissione, verrà trasferiti alla quota di 440 km, da dove, spinti da piccoli propulsori ionici, raggiungeranno la quota operativa di 550 km. Il rilascio dei satelliti avverrà mettendo in rotazione lo stadio in cui sono stati collocati, sfruttando l’effetto inerzia e rinunciando ad attuatori.
Il razzo vettore Falcon 9 di SpaceX, con a bordo i primi 60 satelliti della costellazione Starlink, ideata da Elon Musk per offrire servizi di comunicazione internet ad alta velocità su banda larga in orbita bassa, effettuerà un terzo tentativo di lancio giovedì 23 maggio partendo da Cape Canaveral. A un primo rinvio del lift-off, causa forte vento in quota mercoledì 15 maggio, ne era seguito un secondo imposto dalla necessità di aggiornare il software che gestisce le operazioni di rilascio del carico utile. Il gruppo di 60 satelliti, ciascuno del peso di 227 kg e a forma di pannelli piatti dotati di antenne ad alta potenza di trasmissione, verrà trasferiti alla quota di 440 km, da dove, spinti da piccoli propulsori ionici, raggiungeranno la quota operativa di 550 km. Il rilascio dei satelliti avverrà mettendo in rotazione lo stadio in cui sono stati collocati, sfruttando l’effetto inerzia e rinunciando ad attuatori.
La costellazione Starlink opererà su tre livelli orbitali. I primi 1.600 satelliti saranno collocati sull’orbita di 550 chilometri, il secondo gruppo di 2.800 a 1.150 chilometri e ben 7.500 satelliti saranno distribuiti a un’altezza di 340 chilometri. Un progetto articolato e complesso, da completare nell’arco di un decennio, per un costo di 10 miliardi di dollari.
La capacità operativa sarà raggiunta dopo il lancio del 400esimo satellite e permetterà di iniziare la vendita dei relativi servizi, garantiti da una rete di stazioni terrestri integrata dalle connessioni laser tra gli stessi satelliti.

da Sorrentino | Apr 18, 2019 | Industria, Lanci, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale
 La navicella Cygnus, alla sua undicesima missione operativa per trasferire carichi verso la Stazione Spaziale Internazionale, è stata lanciata con successo alle 22.46 ora italiana di mercoledì 17 aprile, dalla base di lancio dalla base di lancio Wallops Flight Facility della Nasa, in Virginia, lanciatore Antares-230. La navetta cargo Cygnus NG-11 trasporta NUTRISS e Acoustic Diagnostics, i primi due dei sei esperimenti previsti per la missione Beyond, la seconda nello spazio per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, che partirà il 20 luglio e ricoprirà il ruolo di comandante della stazione nella seconda parte della sua permanenza in orbita. Cygnus è composta dal Modulo di Servizio della Northrop Grumman Innovation Systems dal Modulo Cargo Pressurizzato (PCM) in versione avanzata, sviluppato e costruito da Thales Alenia Space, che ha una capacità di carico di 3,5 tonnellate in un volume totale di 27 metri cubici.
La navicella Cygnus, alla sua undicesima missione operativa per trasferire carichi verso la Stazione Spaziale Internazionale, è stata lanciata con successo alle 22.46 ora italiana di mercoledì 17 aprile, dalla base di lancio dalla base di lancio Wallops Flight Facility della Nasa, in Virginia, lanciatore Antares-230. La navetta cargo Cygnus NG-11 trasporta NUTRISS e Acoustic Diagnostics, i primi due dei sei esperimenti previsti per la missione Beyond, la seconda nello spazio per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, che partirà il 20 luglio e ricoprirà il ruolo di comandante della stazione nella seconda parte della sua permanenza in orbita. Cygnus è composta dal Modulo di Servizio della Northrop Grumman Innovation Systems dal Modulo Cargo Pressurizzato (PCM) in versione avanzata, sviluppato e costruito da Thales Alenia Space, che ha una capacità di carico di 3,5 tonnellate in un volume totale di 27 metri cubici.
Quella lanciata è la versione “enhanced” del Modulo Cargo Pressurizzato, caratterizzata da nuova modalità di carico. A differenza di quanto avvenuto in precedenza, quando tutti i carichi utili dovevano essere collocati all’interno del modulo circa quattro giorni prima del lancio, il caricamento di esperimenti scientifici urgenti – inclusi topi vivi – nel Cygnus avviene solo 24 ore prima del lancio. L’undicesima missione di Cygnus è stata ribattezzata con il nome di Roger Chaffee, l’astronauta dell’Apollo 1 perito in un incendio scoppiato durante un pad test. È previsto che Cygnus resti nella Stazione Spaziale Internazionale fino al mese di luglio, quando si celebrerà il cinquantesimo anniversario della missione Apollo 11 ed è atteso l’equipaggio della Soyuz Ms-13 che comprende Parmitano, Skvorcov e Morgan. La S.S. Roger Chaffee dimostrerà, inoltre, anche la capacità della navicella Cygnus di rimanere in orbita dopo la separazione dalla Stazione Spaziale, in supporto a operazioni di servizio come piattaforme per ricerche scientifiche nelle missioni future.
Thales Alenia Space fornisce i moduli cargo a Northrop Grumman fin dall’inizio del Programma Cygnus. Il primo contratto nel 2009 prevedeva il trasporto di nove moduli, mentre il secondo contratto, nel 2016, ne aggiungeva altri nove. Undici PCM operativi più un modulo demo sono stati lanciati fino ad oggi, quattro in versione originale e otto nella versione enhanced. Costruiti da Thales Alenia Space usando un nuovo sistema di saldatura ad attrito, la caratteristica di questo nuovo modulo è un peso più leggero e un design più efficiente che aumenta il peso di carico e il volume, con la capacità di accogliere carichi nonstandard.

da Sorrentino | Mar 22, 2019 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

Il razzo Vega dell’Agenzia Spaziale Europea, progettato e costruito in Italia da Avio, ha messo in orbita il satellite Prisma, acronimo di “PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa”, che condurrà missione prototipale dell’Agenzia spaziale italiana sviluppata per testare tecnologie iperspettrali per l’osservazione della Terra. Il lancio è avvenuto alle 2:50 (ora italiana) della notte tra il 21 e il 22 marzo dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana Francese, sotto la responsabilità di Arianespace. Una missione che esalta le capacità dell’Italia in campo spaziale, combinando le tecnologie satellitari avanzate con l’affidabilità del lanciatore. Il satellite Prisma, frutto della collaborazione tra imprese italiane, guidate da Ohb Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti – terra, volo e lancio – e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica, sarà in grado di monitorare lo stato delle risorse naturali, la qualità dell’aria e i livelli di inquinamento su scala globale da un’orbita di 620 chilometri di quota. Fondamentale, a tale riguardo, la precisione e l’affidabilità di Vega, che a distanza di quatto mesi dall’ultimo lancio ha realizzato con successo la sua 14esima missione, 12 delle quali servite ad avviare missioni dedicate all’osservazione della Terra. Prisma è un satellite innovativo, dotato di una strumentazione elettro-ottica, in grado di lavorare in numerose bande disposte dal visibile al vicino infrarosso, fino all’infrarosso ad onde corte, che permetterà di studiare il nostro pianeta in profondità, riuscendo ad acquisire dati sulla composizione chimica delle aree osservate. A differenza dei sensori ottici passivi satellitari attualmente operativi, che registrano la radiazione solare riflessa dal nostro pianeta in un numero limitato di bande spettrali – solitamente al massimo una decina -, la strumentazione a bordo del satellite è in grado di acquisire 239 bande spettrali, più il canale pancromatico. Di conseguenza, le misurazioni permetteranno agli scienziati di perfezionare le conoscenze riguardanti le risorse naturali e i principali processi ambientali in atto, come i fenomeni legati al cambiamento climatico. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l’acquisizione e l’elaborazione dei dati avverrà al Centro Spaziale dell’Agenzia Spaziale Italiana a Matera. Piena conferma anche per il lanciatore Vega, progettato, sviluppato e realizzato da Avio nello stabilimento laziale di Colleferro, in grado di collocare in orbita satelliti di massa fino a 1.500 kg, che dalla sua entrata in servizio nel 2012 ha compiuto 14 lanci, tutti coronati da successo. Nel corso del 2019 è previsto l’arrivo della versione più performante denominata Vega C e, dal 2024 dal Vega E (Evolution), il cui nuovo motore a ossigeno liquido e metano dello stadio superiore, M10, è stato testato con successo nel mese di novembre 2018.

da Sorrentino | Mar 12, 2019 | Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari
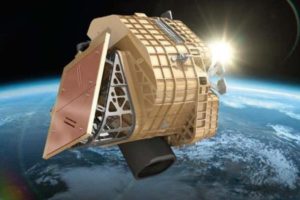 L’Agenzia Spaziale Italiana ha comunicato che il lancio del razzo VEGA per la messa in orbita del Satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio). La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio. La nuova data di “partenza” di Vega dal Centro Spaziale di Kourou, nella Guyana francese, è fissata per giovedì 21 marzo, alle 22:50 ora locale, quando in Italia saranno le 1:50 notturne di venerdì 22 marzo. Il satellite italiano PRISMA si trova nella ogiva del razzo vettore VEGA, progettato e costruito in Italia da Avio di Colleferro (RM), che lo posizionerà nella sua orbita operativa prevista. Prisma studierà la Terra dalla quota di 620 km utilizzando un sensore ottico iperspettrale, che può aprire nuovi scenari per il controllo dei processi ambientali del nostro pianeta. Il satellite è stato realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica e lo ha costruito costruito negli stabilimenti fiorentini di Campi Bisenzio. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l’acquisizione e l’elaborazione dei dati avverrà dal Centro Spaziale di Matera.
L’Agenzia Spaziale Italiana ha comunicato che il lancio del razzo VEGA per la messa in orbita del Satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio). La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio. La nuova data di “partenza” di Vega dal Centro Spaziale di Kourou, nella Guyana francese, è fissata per giovedì 21 marzo, alle 22:50 ora locale, quando in Italia saranno le 1:50 notturne di venerdì 22 marzo. Il satellite italiano PRISMA si trova nella ogiva del razzo vettore VEGA, progettato e costruito in Italia da Avio di Colleferro (RM), che lo posizionerà nella sua orbita operativa prevista. Prisma studierà la Terra dalla quota di 620 km utilizzando un sensore ottico iperspettrale, che può aprire nuovi scenari per il controllo dei processi ambientali del nostro pianeta. Il satellite è stato realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica e lo ha costruito costruito negli stabilimenti fiorentini di Campi Bisenzio. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l’acquisizione e l’elaborazione dei dati avverrà dal Centro Spaziale di Matera.

 Ennesimo esame superato per SpaceX che ha effettuato un lancio notturno con il potente razzo Falcon Heay, alla sua terza missione denominata “Space Test Program-2 (STP-2), lo stesso che nel 2018 accompagnò il viaggio di una Tesla Roadstar verso Marte. A bordo 24 satellite da posizione in tre orbite diverse durante le sei ore successive alla partenza da Cape Canaveral, avvenuta quando in Italia erano le 8.28 del mattino. L’operazione di rilascio in tempi e a quote orbitali differenti del carico utile è stata prevista mediante quattro accensioni del secondo stadio del Falcon Heavy. Come da programma, SpaceX ha recuperato e fatto riatterrare sulla piattaforma del centro spaziale in Florida i due booster del razzo vettore, che hanno toccato terra in verticale rispettivamente 8’45” e 11’15” dopo il lancio. Il carico utile per complessivi 3,7 tonnellate comprende una serie di strumentazioni ed esperimenti scientifici della NASA, del NOAA, dell’Aeronautica militare statunitense, e quelli messi a punto da università e piccole compagnie spaziali private. Tra gli utenti privati figura anche Celestis, azienda specializzata nel lancio di ceneri umane nello Spazio, che ha trasferito in orbita, all’interno della capsula Orbital Test Bed (in cui peraltro la NASA ha posizionato l’orologio atomico miniaturizzato Deep Space Atomic Clock,, le urne con le cremazioni di 152 persone, comprese quelle dell’astronauta americano Bill Pogue, protagonista di una missione di 84 giorni a bordo dello Skylab negli anni ’70. Heritage Flight, questo il nome del carico dell’ultimo viaggio, resterà in orbita 25 anni prima di ricadere e bruciare dissolvendosi nell’atmosfera terreste. La parte scientifica più interessante è legata alla Planetary Society, che ha lanciato LightSail 2, un piccolo satellite che una volta in orbita dispiegherà una vela solare. Un programma sostenuto da crowfunding che permetterà di testare i vantaggi della spinta prodotti dai fotoni per viaggiare nel sistema solare senza ausilio di motori e pannelli solari.
Ennesimo esame superato per SpaceX che ha effettuato un lancio notturno con il potente razzo Falcon Heay, alla sua terza missione denominata “Space Test Program-2 (STP-2), lo stesso che nel 2018 accompagnò il viaggio di una Tesla Roadstar verso Marte. A bordo 24 satellite da posizione in tre orbite diverse durante le sei ore successive alla partenza da Cape Canaveral, avvenuta quando in Italia erano le 8.28 del mattino. L’operazione di rilascio in tempi e a quote orbitali differenti del carico utile è stata prevista mediante quattro accensioni del secondo stadio del Falcon Heavy. Come da programma, SpaceX ha recuperato e fatto riatterrare sulla piattaforma del centro spaziale in Florida i due booster del razzo vettore, che hanno toccato terra in verticale rispettivamente 8’45” e 11’15” dopo il lancio. Il carico utile per complessivi 3,7 tonnellate comprende una serie di strumentazioni ed esperimenti scientifici della NASA, del NOAA, dell’Aeronautica militare statunitense, e quelli messi a punto da università e piccole compagnie spaziali private. Tra gli utenti privati figura anche Celestis, azienda specializzata nel lancio di ceneri umane nello Spazio, che ha trasferito in orbita, all’interno della capsula Orbital Test Bed (in cui peraltro la NASA ha posizionato l’orologio atomico miniaturizzato Deep Space Atomic Clock,, le urne con le cremazioni di 152 persone, comprese quelle dell’astronauta americano Bill Pogue, protagonista di una missione di 84 giorni a bordo dello Skylab negli anni ’70. Heritage Flight, questo il nome del carico dell’ultimo viaggio, resterà in orbita 25 anni prima di ricadere e bruciare dissolvendosi nell’atmosfera terreste. La parte scientifica più interessante è legata alla Planetary Society, che ha lanciato LightSail 2, un piccolo satellite che una volta in orbita dispiegherà una vela solare. Un programma sostenuto da crowfunding che permetterà di testare i vantaggi della spinta prodotti dai fotoni per viaggiare nel sistema solare senza ausilio di motori e pannelli solari.


 Il razzo vettore Falcon 9 di SpaceX, con a bordo i primi 60 satelliti della costellazione Starlink, ideata da Elon Musk per offrire servizi di comunicazione internet ad alta velocità su banda larga in orbita bassa, effettuerà un terzo tentativo di lancio giovedì 23 maggio partendo da Cape Canaveral. A un primo rinvio del lift-off, causa forte vento in quota mercoledì 15 maggio, ne era seguito un secondo imposto dalla necessità di aggiornare il software che gestisce le operazioni di rilascio del carico utile. Il gruppo di 60 satelliti, ciascuno del peso di 227 kg e a forma di pannelli piatti dotati di antenne ad alta potenza di trasmissione, verrà trasferiti alla quota di 440 km, da dove, spinti da piccoli propulsori ionici, raggiungeranno la quota operativa di 550 km. Il rilascio dei satelliti avverrà mettendo in rotazione lo stadio in cui sono stati collocati, sfruttando l’effetto inerzia e rinunciando ad attuatori.
Il razzo vettore Falcon 9 di SpaceX, con a bordo i primi 60 satelliti della costellazione Starlink, ideata da Elon Musk per offrire servizi di comunicazione internet ad alta velocità su banda larga in orbita bassa, effettuerà un terzo tentativo di lancio giovedì 23 maggio partendo da Cape Canaveral. A un primo rinvio del lift-off, causa forte vento in quota mercoledì 15 maggio, ne era seguito un secondo imposto dalla necessità di aggiornare il software che gestisce le operazioni di rilascio del carico utile. Il gruppo di 60 satelliti, ciascuno del peso di 227 kg e a forma di pannelli piatti dotati di antenne ad alta potenza di trasmissione, verrà trasferiti alla quota di 440 km, da dove, spinti da piccoli propulsori ionici, raggiungeranno la quota operativa di 550 km. Il rilascio dei satelliti avverrà mettendo in rotazione lo stadio in cui sono stati collocati, sfruttando l’effetto inerzia e rinunciando ad attuatori.
 La navicella Cygnus, alla sua undicesima missione operativa per trasferire carichi verso la Stazione Spaziale Internazionale, è stata lanciata con successo alle 22.46 ora italiana di mercoledì 17 aprile, dalla base di lancio dalla base di lancio Wallops Flight Facility della Nasa, in Virginia, lanciatore Antares-230. La navetta cargo Cygnus NG-11 trasporta NUTRISS e Acoustic Diagnostics, i primi due dei sei esperimenti previsti per la missione Beyond, la seconda nello spazio per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, che partirà il 20 luglio e ricoprirà il ruolo di comandante della stazione nella seconda parte della sua permanenza in orbita. Cygnus è composta dal Modulo di Servizio della Northrop Grumman Innovation Systems dal Modulo Cargo Pressurizzato (PCM) in versione avanzata, sviluppato e costruito da Thales Alenia Space, che ha una capacità di carico di 3,5 tonnellate in un volume totale di 27 metri cubici.
La navicella Cygnus, alla sua undicesima missione operativa per trasferire carichi verso la Stazione Spaziale Internazionale, è stata lanciata con successo alle 22.46 ora italiana di mercoledì 17 aprile, dalla base di lancio dalla base di lancio Wallops Flight Facility della Nasa, in Virginia, lanciatore Antares-230. La navetta cargo Cygnus NG-11 trasporta NUTRISS e Acoustic Diagnostics, i primi due dei sei esperimenti previsti per la missione Beyond, la seconda nello spazio per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, che partirà il 20 luglio e ricoprirà il ruolo di comandante della stazione nella seconda parte della sua permanenza in orbita. Cygnus è composta dal Modulo di Servizio della Northrop Grumman Innovation Systems dal Modulo Cargo Pressurizzato (PCM) in versione avanzata, sviluppato e costruito da Thales Alenia Space, che ha una capacità di carico di 3,5 tonnellate in un volume totale di 27 metri cubici.


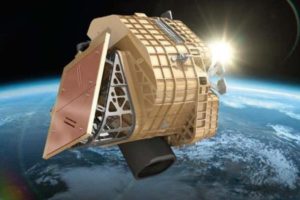 L’Agenzia Spaziale Italiana ha comunicato che il lancio del razzo VEGA per la messa in orbita del Satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio). La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio. La nuova data di “partenza” di Vega dal Centro Spaziale di Kourou, nella Guyana francese, è fissata per giovedì 21 marzo, alle 22:50 ora locale, quando in Italia saranno le 1:50 notturne di venerdì 22 marzo. Il satellite italiano PRISMA si trova nella ogiva del razzo vettore VEGA, progettato e costruito in Italia da Avio di Colleferro (RM), che lo posizionerà nella sua orbita operativa prevista. Prisma studierà la Terra dalla quota di 620 km utilizzando un sensore ottico iperspettrale, che può aprire nuovi scenari per il controllo dei processi ambientali del nostro pianeta. Il satellite è stato realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica e lo ha costruito costruito negli stabilimenti fiorentini di Campi Bisenzio. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l’acquisizione e l’elaborazione dei dati avverrà dal Centro Spaziale di Matera.
L’Agenzia Spaziale Italiana ha comunicato che il lancio del razzo VEGA per la messa in orbita del Satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio). La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio. La nuova data di “partenza” di Vega dal Centro Spaziale di Kourou, nella Guyana francese, è fissata per giovedì 21 marzo, alle 22:50 ora locale, quando in Italia saranno le 1:50 notturne di venerdì 22 marzo. Il satellite italiano PRISMA si trova nella ogiva del razzo vettore VEGA, progettato e costruito in Italia da Avio di Colleferro (RM), che lo posizionerà nella sua orbita operativa prevista. Prisma studierà la Terra dalla quota di 620 km utilizzando un sensore ottico iperspettrale, che può aprire nuovi scenari per il controllo dei processi ambientali del nostro pianeta. Il satellite è stato realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica e lo ha costruito costruito negli stabilimenti fiorentini di Campi Bisenzio. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l’acquisizione e l’elaborazione dei dati avverrà dal Centro Spaziale di Matera.








